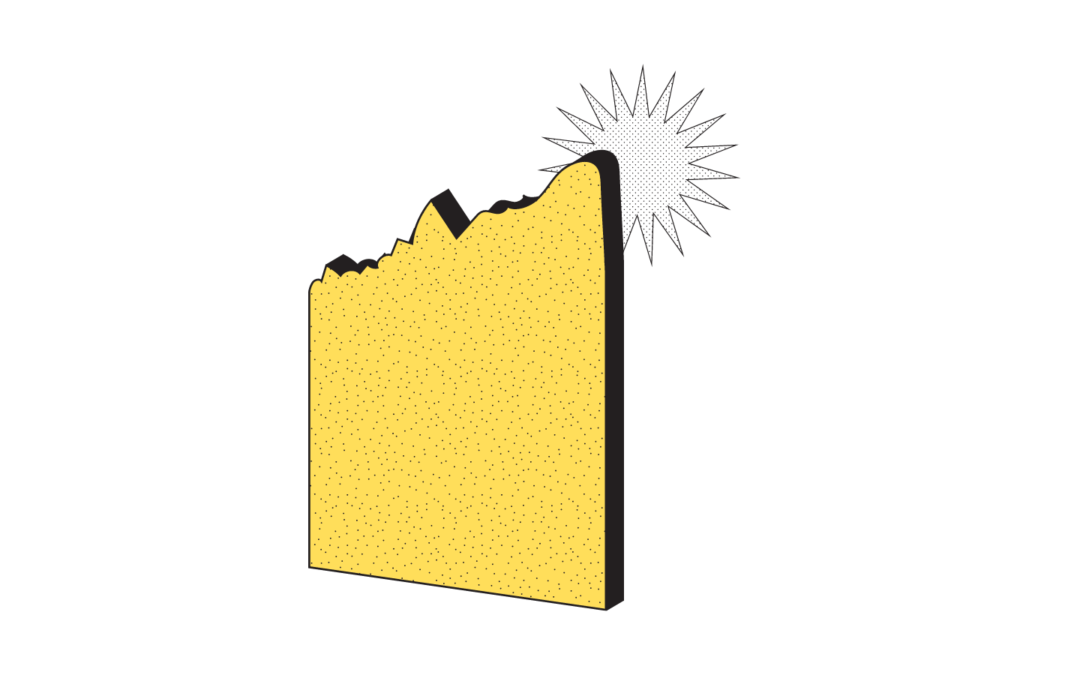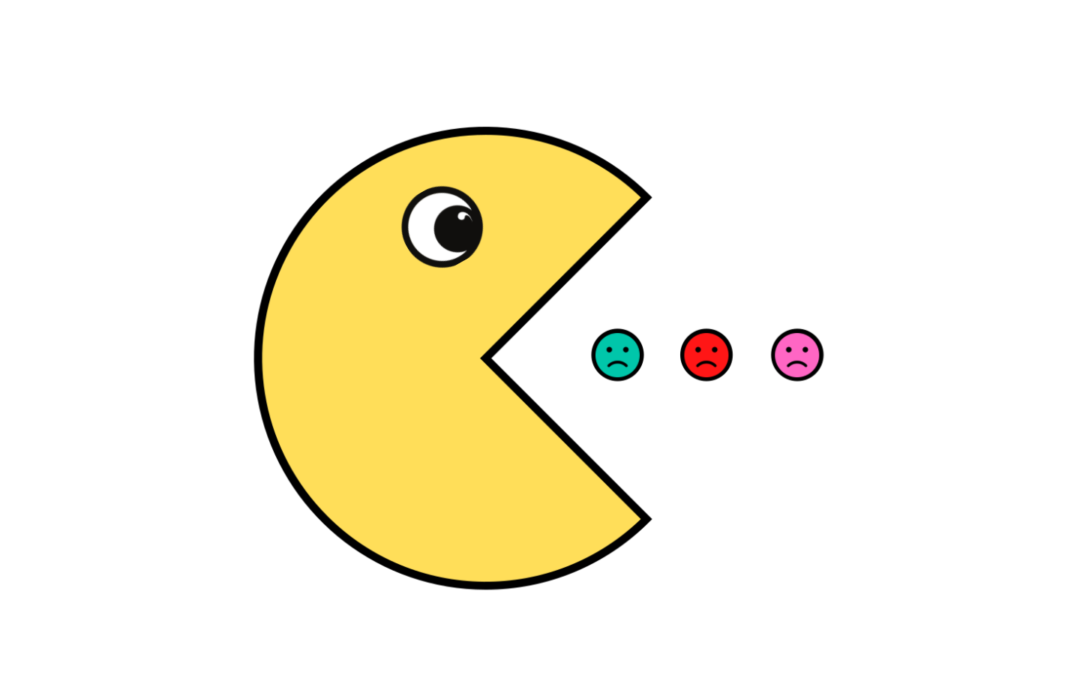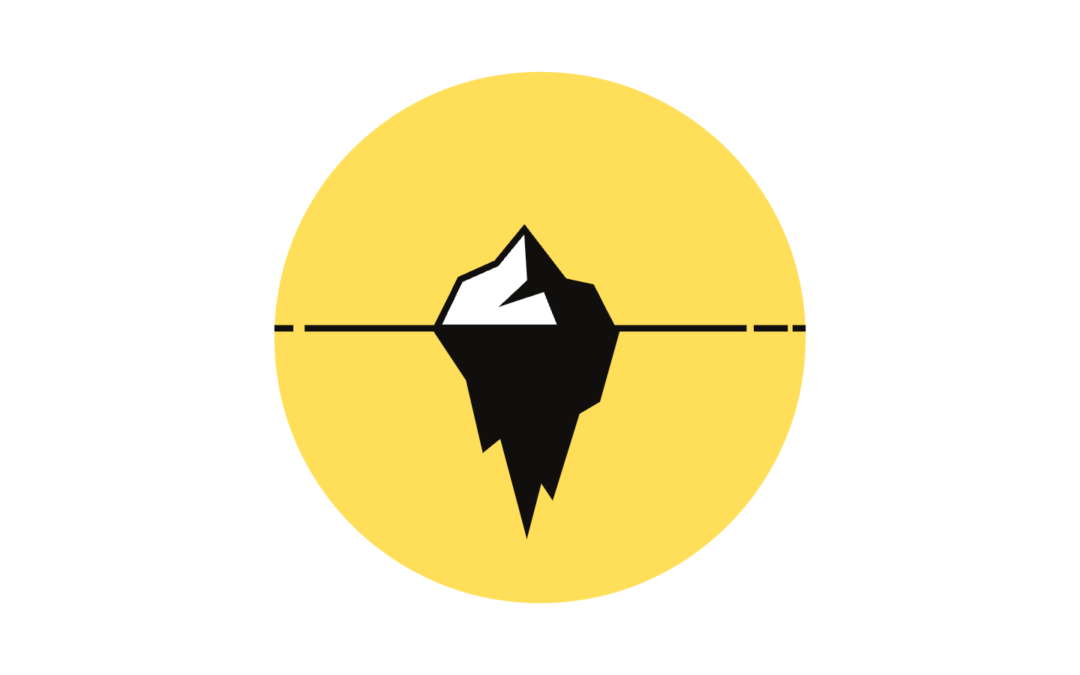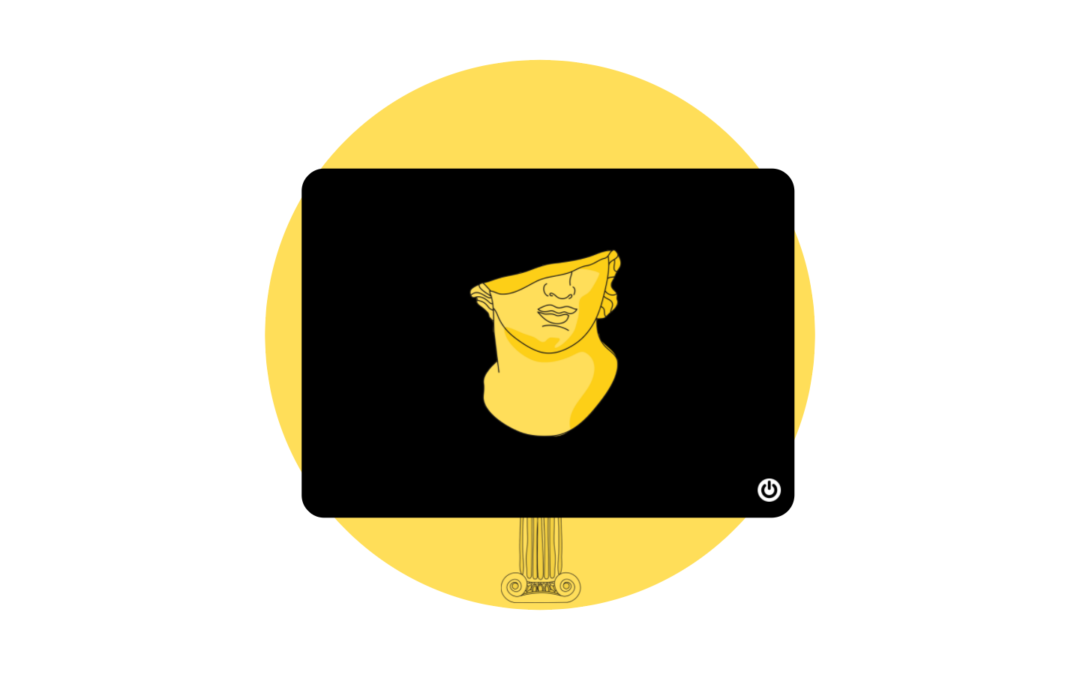Dentro le strategie del Financial Times, con Renée Kaplan
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
C’è una new entry nel ristretto club mondiale del “milione digitale”: il Financial Times.
Dieci giorni fa, il quotidiano britannico ha infatti comunicato di avere superato la soglia del 1.000.000 di abbonati al proprio sito.
L’annuncio del Financial Times è arrivato esattamente tre anni dopo il raggiungimento di un altro traguardo, quello del milione di lettori paganti totali (dato che includeva anche gli abbonati al quotidiano cartaceo), che era stato tagliato nel 2019.
L’FT, come sai, è stato tra i pionieri della reader revenue: ha lanciato il proprio paywall vent’anni fa – nel 2002. E il suo approccio strategico, in particolare negli ultimi anni, è stato vincente.
Dopo essere stato acquisito dal gruppo finanziario giapponese Nikkei nel 2015, il giornale è stato in grado di espandere e aumentare la forza del proprio brand anche oltre i confini britannici: oggi 1 abbonato su 5 è statunitense.
Una delle artefici di questo percorso di successo è Renée Kaplan, che è all’FT dal 2015, e che dal 2020 ricopre il ruolo di Head of Digital Editorial Development.
Prima di approdare all’FT, Kaplan è stata vicedirettrice editoriale di France24 e CCO dell’agenzia Havas Worldwide a Parigi.
Con Kaplan – che, tra le altre cose, è affezionata lettrice di Ellissi! – abbiamo avuto modo di conoscerci qualche anno fa, al termine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia.
Oggi il suo ruolo è la sintesi perfetta dell’ibridazione che ogni media company dovrebbe abbracciare per affrontare le sfide del presente e del futuro: nella sua posizione – a metà tra editoriale e prodotto – supervisiona vari team, tra cui quelli dedicati ai podcast, alle newsletter e ai publishing project, gli hub di contenuto tematico del giornale.
Proprio per scoprire la sua visione strategica sul futuro dell’FT e dei media in generale, ho deciso di contattarla e chiederle di partecipare a una puntata di Ellissi Meets (trovi tutte le puntate nell’archivio).
Qui sotto c’è la trascrizione della conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa: abbiamo parlato di newsletter, di podcast, di creator economy e di FT Edit, la nuova app del Financial Times che verrà lanciata a fine mese.
Alla prossima Ellissi
Valerio

VB: Ciao Renée, benvenuta su Ellissi. Partiamo dalle newsletter, che al Financial Times non mancano: ne avete una cinquantina, di cui circa metà automatiche e metà autoriali.
RK: Sì, esatto. Quelle automatiche sono dei digest automatici di contenuti creati intorno a dei temi verticali; quelle autoriali, invece, veicolano la voce e la competenza di uno specifico giornalista. Tra queste ultime alcune sono gratuite, altre invece sono a pagamento.
Vorrei approfondire la strategia delle newsletter autoriali. Servono più a catturare nuovi abbonati, oppure a mantenere quelli che già lo sono? Le consideri più uno strumento di acquisition o di retention?
Ti direi che quasi tutte le nostre newsletter autoriali sono costruite per aumentare la longevità e la permanenza dei nostri abbonati. I dati ci confermano che le newsletter sono lo strumento di retention più potente che abbiamo. Tra l’altro funzionano soprattutto sui segmenti di pubblico che sono più a rischio di cancellazione. Tuttavia, di recente, abbiamo deciso di introdurre una serie di newsletter finalizzate all’acquisizione di nuovi abbonati. Questo perché in generale ci interessa differenziare le strategie commerciali e provare a fare cose diverse.
Qual è una newsletter del Financial Times che sta raggiungendo i risultati migliori? Ci faresti un esempio?
Guarda, te ne indico due. La prima è FirstFT, la nostra newsletter mattutina che presenta i titoli della giornata. FirstFT ha tre edizioni differenti spalmate su tre fusi orari differenti. Riporta la notizia principale in primissimo piano e poi, a seguire, altre cinque storie che riteniamo indispensabili per i nostri lettori. Segue qualche altro consiglio, sostanzialmente a corredo dei fatti principali, e una piccola riflessione finale. Nell’ultimo anno, grazie anche al lavoro della nostra nuova head of newsletters Sarah Ebner, la abbiamo migliorata molto. E i risultati sono stati straordinari: sia in termini di numero di iscritti che di open rate è di gran lunga la nostra newsletter migliore.
Interessante. E l’altro esempio?
L’altra newsletter è Unhedged, che è scritta da Rob Armstrong. Rob è uno dei nostri commentatori più esperti, vive negli Stati Uniti e scrive sia di mercati che dello stato generale della finanza. La newsletter, che abbiamo lanciato nel 2021, ha un tono di voce molto personale e molto caratteristico. Piace a tantissime persone perché le avvicina ai pensieri di giornalista che rispettano e apprezzano – il che contribuisce a sviluppare un senso di relazione molto forte. Il loro pensiero è: “Se leggo quello che Rob Armstrong fa e pensa ogni giorno, sarò sempre un passo avanti agli altri”.
Hai parlato di “personalità”, dell’importanza di avere voci riconoscibili. Oggi si parla molto di creator economy – come valuti il proliferare di questi piccoli media brand che nascono e crescono al di fuori delle redazioni tradizionali, spesso incentrati sul carisma e sulla popolarità di una singola persona? Come dovrebbe rapportarsi un giornale tradizionale come quello del Financial Times a questa tendenza?
Credo che il termine creator economy sia piuttosto abusato, che sia una specie di buzzword. In fondo una redazione non è già in sé un gruppo folto ed eterogeneo di pensatori indipendenti, “creator” e giornalisti di grande esperienza? C’è un hype esagerato verso l’economia dei creator, talvolta persino pericoloso: penso al rischio di burnout, soprattutto. Doversi occupare di tutti gli aspetti di una media company – pubblicazione, creazione, distribuzione, monetizzazione – e al contempo guadagnare abbastanza soldi per vivere, senza la rete di supporto fornita da una testata: come si fa? Essere indipendenti e “volare da soli” può essere senz’altro stimolante, ma rischia di diventare un’utopia. Detto questo, ci sono degli elementi della creator economy che vanno preservati e accolti anche all’interno delle redazioni. Il caso di Unhedged va proprio in questo senso – l’intenzione di sviluppare voci forti e riconoscibili in grado di creare un legame diretto con il pubblico, basato in primo luogo sulla fiducia.
Avete mai valutato la possibilità di acquisire una newsletter di successo esterna e di inglobarla nell’offerta del Financial Times, un po’ come l’Atlantic ha fatto di recente con alcuni autori su Substack?
Per ora produciamo tutto in casa, ma mai dire mai: nel mondo dei contenuti a pagamento anche le aziende più brave e posizionate meglio riescono a crescere organicamente solo fino a un certo punto. Considera anche che la concorrenza nel mondo delle subscription sta diventando sempre più dura. Ci sono sempre più competitor. Un altro modo per raggiungere una certa crescita, quindi, è “comprarsi” quella crescita: e anche se non è una cosa a cui pensiamo in questo momento potrebbe diventarlo in futuro.
Cambiamo argomento: parliamo di podcast. Sulla produzione audio, negli ultimi due anni, avete investito molto. Come si inseriscono i podcast nella strategia generale del Financial Times?
Oggi per noi i podcast sono soprattutto uno strumento di reach e di acquisizione: li usiamo per offrire alle persone la possibilità di assaggiare gratuitamente il nostro giornalismo e di entrare in relazione con il nostro brand. Con l’idea, a un certo punto, di convincerli a pagare per accedere alla nostra intera offerta editoriale. Avendo storicamente un paywall molto rigido, il cuore della nostra offerta audio e video è sempre rimasto gratuito: crediamo che i podcast possano aiutarci a coltivare una nuova audience che magari non conosce ancora a fondo il Financial Times o la nostra offerta editoriale.
Non a caso la nostra strategia sui podcast punta molto al mercato statunitense, che è quello dove pensiamo di avere più margini di crescita: negli USA abbiamo una audience molto grande ma un market share ancora relativamente piccolo. Vogliamo dunque che un pubblico sempre più ampio, attraverso i podcast, possa familiarizzare con una pubblicazione come la nostra, e che si accorga di quanto possa essere rilevante nella loro quotidianità.
Uno strumento che vive alla cima del funnel di acquisizione, quindi.
Assolutamente. Tuttavia, come sai, il problema enorme con i podcast è il tracciamento dei dati: circa il 90% degli ascolti dei nostri podcast avviene off-site. È difficile analizzare con precisione la journey di conversione in abbonamenti generata da un podcast ospitato da un’altra piattaforma. Anche per questo, per ora, ci affidiamo soprattutto a metriche legate alla reach e alla massima acquisizione.
Ma li monetizzate comunque, attraverso la pubblicità.
Finanziamo i nostri podcast in questo modo, sì. L’audio advertising genera oggi grandi profitti per l’FT ed è in continua crescita. Quindi, comunque la si guardi, quella sui podcast è per noi una storia di successo.
Piattaforme come Apple Podcast e Spotify stanno cominciando a introdurre la possibilità di abbonarsi ai podcast. Non esiste ancora un modo per rendere possibile a un abbonato dell’FT, ad esempio, di accedere a tutti i podcast premium della testata direttamente sulla piattaforma. L’esperienza ha quindi livelli di frizione altissimi, ed è difficile che cambi: servirebbe un’integrazione di database che al momento è impensabile.
Sì, l’attuale customer journey concessa dalle piattaforme è estremamente scomoda e il tracciamento, anche in questo caso, non è particolamente efficace. Tempo fa abbiamo sperimentato con un podcast a pagamento: era un prodotto editoriale interessante, ma probabilmente ancora non era pronto per il mercato. Quindi, per tutte queste ragioni, preferiamo mantenere aperto l’accesso ai podcast.
Parliamo di un trend interessante, quello legato al contenuto non strettamente “news”, che per testate come il New York Times si sta rivelando un potente strumento di conversione in abbonamento – dai cruciverba alla cucina. È un settore cui si sta muovendo anche il Financial Times?
Quello del New York Times è sicuramente un caso interessante. Ma il loro è un giornale generalista, al contrario di noi, che siamo molto più specializzati e B2B. Non credo l’FT avrà mai un verticale di cucina – puntiamo, piuttosto, a creare dei content hub su temi a noi affini, come Lavoro, Leadership e Carriera. Un esempio concreto è quello di Working It, un ecosistema di prodotti dedicati a come migliorare il modo in cui lavoriamo: al momento l’offerta include un podcast e, a breve, comprenderà anche una newsletter.
Cerchiamo sempre di ragionare dalla prospettiva del nostro utente-tipo: qual è un servizio che può tornare utile a quella determinata tipologia di persona? Vogliamo però evitare di diluire il potere e la rilevanza del nostro brand, che è la nostra forza, e il suo posizionamento sul mercato.
State anche per lanciare una nuova app, FT Edit. Qual è l’idea dietro questo esperimento?
FT Edit offrirà accesso a una selezione di 8 articoli al giorno a un punto di prezzo più basso rispetto all’abbonamento completo. L’idea è quella di intercettare un’audience più ampia, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Al momento siamo in fase di testing: l’app dovrebbe uscire alla fine di marzo su App Store, e sarà inizialmente disponibile solo per iOS.
Curioso di vederla. Ti faccio un’ultima domanda, anche provocatoria, legata a un tema che mi sta particolarmente a cuore. Pensi che l’articolo – inteso come generico formato di distribuzione del contenuto testuale – sia in qualche modo superato? Se ci pensi, a parte qualche eccezione come quella dei liveblog, l’articolo è rimasto uguale a cinquanta o cento anni fa: è semplicemente la trasposizione digitale di qualcosa che esisteva da sempre su carta. Pensi ci sia margine per ripensarlo e di innovarlo per il digitale?
Non credo che l’articolo sia morto. Penso che azioni come leggere e scrollare una pagina web non siano destinate a scomparire nel breve periodo. Gli articoli sono ancora un formato rilevante, anche nella loro versione più tradizionale. Allo stesso tempo, però, ci sono dei trend che non possiamo ignorare. Penso alle Airpods, che hanno rivoluzionato il modo in cui ci interfacciamo con i nostri device, creando un’interazione sempre più ‘hands-free’. È un discorso più ampio quindi, che si lega ad esempio alla necessità di essere più multitasking, di fruire di media diversi contemporaneamente, di adattarci alle dimensioni degli schermi. Penso sia necessario continuare a innovare, a sperimentare, a perfezionare formati di fruizione del contenuto che siano adatti a differenti utenti e alle più varie tipologie di utilizzo – soprattutto nel contesto della competizione per l’attenzione. Sono una grande fan degli ‘Smiths’, Ben e Justin, che come sai stanno lavorando alla nascita di un nuovo ambizioso progetto editoriale globale. Entrambi hanno dichiarato di voler lavorare a un ripensamento del formato dell’articolo. È una sfida interessante, ma tutt’altro che semplice. Staremo a vedere.
Grazie, Renée. E buon lavoro.
Grazie a te.
{vb} Ciao Donata, grazie di essere qui. Dimmi, anche tu tracci ogni attività della tua vita quotidiana?
{dc} No, ho smesso! L’ho fatto per due anni con un braccialetto di monitoraggio dell’attività fisica e del sonno, prima dell’arrivo di molti smartwatch sul mercato — ma sono troppo performativa, alla fine non mi divertivo più. Adesso se raccolgo dati su qualche aspetto della mia quotidianità lo faccio creando database con oggetti fisici, almeno vado offline ogni tanto.
E come è nato il tuo interesse per il giornalismo dei dati e per la comunicazione visuale? Ci conosciamo da anni e non te l’ho mai chiesto.
Credo sia stato a partire dalla pubblicazione del progetto The Migrant Files, nel 2013, a cura di un network di giornalisti europei tra cui i miei attuali soci di Dataninja Andrea Nelson Mauro e Alessio Cimarelli: per la prima volta qualcuno aveva raccolto e verificato i dati dei naufragi nel Mediterraneo, mettendo insieme diverse fonti giornalistiche e istituzionali e creando il database più affidabile esistente su questo fenomeno. I numeri, spaventosi, che indicavano l’esistenza di un vero e proprio cimitero nel nostro mare, venivano poi visualizzati in tempo reale su una semplice mappa a simboli proporzionali, di grande impatto. Non esistevano ancora le banche dati pubbliche dell’UNCHR o dell’OIM, quindi quel lavoro basato sui dati fu veramente una pietra miliare del data journalism europeo, infatti ricevette diversi premi l’anno successivo.
Come giornalista che si è formata nel mondo della cooperazione internazionale sono rimasta particolarmente colpita dalla potenza di questo lavoro. Nel 2014 ho avuto la fortuna di mettermi alla prova partecipando al percorso di formazione sul data journalism organizzato da La Stampa Academy con Google, formando una squadra con altre giornaliste e designer. Vincemmo il contest finale, con la possibilità di produrre un lavoro data driven per il quotidiano piemontese. Poi ho continuato a collaborare con Dataninja e nel 2019 abbiamo lanciato la prima scuola di formazione sui dati.
La pandemia che stiamo vivendo ha sicuramente contribuito a rimettere i ‘numeri’ al centro del flusso informativo: tu stessa, nel libro, la definisci “l’evento più data-informed della storia”. Puoi spiegarmi che cosa è successo in questi due anni, secondo te, e che impatti quanto accaduto potrebbe avere nel nostro rapporto con i dati sul medio-lungo termine?
È una definizione che abbiamo usato in Dataninja quando ci siamo trovati a intervenire in tantissimi dibattiti pubblici che avevano al centro i dati della pandemia: nessuno di noi ha studiato medicina o ha competenze di epidemiologia, eppure il fatto di lavorare con i dati ci ha fatti diventare un punto di riferimento non per capire l’impatto del virus o delle politiche di contenimento sulla salute delle persone, ma semplicemente per interpretare i grafici che ormai comparivano ovunque, anche in prima serata in tv. Ora ci sembra normale, ma un grafico a linee commentato in un talk show televisivo non era assolutamente frequente prima di marzo 2020.
Ci siamo resi conto che i dati ci riguardano, perché vengono usati dalla politica per prendere decisioni che influenzano la nostra vita quotidiana, anche se ovviamente lo fanno da sempre. Durante un’emergenza sanitaria è diventato molto più evidente. Sul medio lungo termine secondo me è aumentato l’interesse delle persone nel capire percentuali, dati e grafici citati nelle notizie, lo dimostra anche l’enorme seguito dei divulgatori scientifici sui social. Ma aumenta anche l’uso e l’abuso che se ne fa per portare avanti le proprie posizioni. In questo momento circolano grafici e dati interpretati in modo diverso da no vax e pro vax, per fare un esempio.
Negli ultimi anni quasi tutti i giornali hanno introdotto pratiche di data journalism e di data visualization nel loro ciclo di produzione quotidiana. In Italia siamo arrivati a un punto soddisfacente, sotto questo aspetto, oppure resta ancora molto da fare? Come la vedi?
Secondo me la maggior parte delle testate si è resa conto della necessità di avere specialisti nel team o almeno come collaboratori fissi. Manca ancora però “la cultura del dato” trasversale, intesa come l’interesse e la capacità di usare i dati per migliorare la qualità di una notizia. Mi ha colpito il fatto che al Financial Times esista la figura della statistical journalist (che è l’italiana Federica Cocco), cioè la persona che aiuta tutta la redazione a usare correttamente numeri e statistiche nelle notizie. Fare data journalism non vuol dire per forza pubblicare data visualization spettacolari alla New York Times, ma avere una redazione preparata nella lettura, nell’interpretazione e nel racconto del dato.
Il dato è politico, ed è filtrato dai bias: i bias di chi li raccoglie, di chi li analizza, e di chi li interpreta — anche dei lettori, per esempio. Secondo te cosa possiamo fare per sviluppare una migliore conoscenza dei nostri stessi bias e imparare magari a combatterli? Quali strumenti abbiamo a disposizione?
Riconoscere che i bias esistono e che non ne siamo immuni, perché le nostre idee sul mondo dipendono dal contesto in cui siamo cresciuti, dalle nostre esperienze personali, dalla nostra dieta mediatica e dalla bolla di persone che frequentiamo. Secondo me l’unico modo è adottare un atteggiamento curioso, aperto, e farsi moltissime domande davanti a dati e grafici. Le autrici di Data Feminism Catherine D’Ignazio e Lauren Klein propongono di partire dal chi (chi ha raccolto i dati, chi è beneficiato da questa raccolta, chi ne sarà penalizzato); Hans Rosling, divulgatore e medico svedese, in Factfulness suggerisce di tenere a bada la nostra visione iperdrammatica del mondo facendo attenzione a 10 istinti o “megaequivoci” che abbiamo nell’interpretare i dati; Tim Harford in The Data Detective consiglia di mettere da parte i sentimenti, perché anche di fronte ai numeri reagiamo con emotività, l’importante è riconoscerlo.
Secondo i dati OCSE PISA, il 46,3% degli italiani tra i 16 e 65 anni dimostra un livello di analfabetizzazione funzionale piuttosto grave (di livello 1 e livello 2). In pratica si tratta di persone che non sono in grado di comprendere e interpretare correttamente ciò che leggono o che ascoltano. Secondo te la data visualization è un’arma per combattere questo problema, oppure c’è il rischio che possa creare una barriera ancora maggiore? Del resto molte infografiche non sono così semplici da capire.
La penso come l’esperto di infografiche Alberto Cairo: un grafico o una data visualization non sono opere d’arte, vanno lette, esplorate, non ammirate. Questa competenza viene chiamata graphicacy o data literacy ed è come saper parlare una lingua straniera. Bisogna allenarsi a farsi molte domande davanti a una data visualization, altrimenti si rischia di cadere nelle trappole della disinformazione anche in questo campo.
A proposito di Alberto Cairo. In un suo libro di qualche anno fa scriveva che le infografiche erano state usurpate dalle aziende di pubbliche relazioni e dal marketing, e le definiva “poster infantili utilizzati come clickbait”. Anche tu hai notato una deriva simile, un utilizzo commerciale e di facciata del dato per evitare di comunicare ciò che si preferirebbe tenere nascosto?
Sicuramente il data storytelling affascina e che venga usato nel marketing (ma anche nell’attivismo) credo sia normale: ma dipende da noi, da una diffusa incompetenza con i numeri (innumeracy) che blocca ogni pensiero critico o giudizio. In un bel pezzo su The Atlantic i giornalisti responsabili di un database sui dati covid negli Stati Uniti smontano i miti dei dati dicendo che “non sono niente di speciale”, sono solo “un po’ di considerazioni qualitative organizzate in un modo quantitativo”. Messa così, potrebbe aiutarci a essere meno timidi davanti ai dati, anche quelli usati per ingannarci come consumatori.
Nel suo libro “The Laws of Simplicity”, John Maeda dice che “Il segreto della semplicità risiede nel sottrarre ciò che è ovvio e aggiungere ciò che è significativo”. Costruire una buona data visualization significa questo — semplificare e mettere in ordine? Oppure è una visione riduttiva di quella che, orami, è una vera e propria arte?
Dipende sempre dal pubblico a cui ci rivolgiamo e al nostro obiettivo. Sempre in Data Feminism le autrici mettono in guardia sul minimalismo delle data visualization perché il rigore associato ai grafici e ai numeri potrebbe alimentare il loro potere dis-informativo. In realtà nessun grafico è imparziale, l’autore o l’autrice hanno sempre un interesse o un obiettivo. Il più importante e condiviso credo possa essere quello di mettere il pubblico nelle migliori condizioni di capire la notizia. In alcuni casi sarà meglio semplificare, in altri invece anche organizzare installazioni fisiche di dati, magari partecipative, in luoghi pubblici, per far toccare, percepire e ricordare meglio i dati che vogliamo raccontare.
Guardando al futuro. In quali aree del giornalismo pensi che i dati possano rivestire un ruolo più importante nel migliorare la nostra comprensione del mondo? Dove c’è più spazio e dove più necessità dell’intervento dei dati?
Come dicevo prima, più che dell’intervento dei dati servirebbe più data literacy nelle redazioni e anche tra i lettori. In ogni caso sicuramente servirebbero più dati, e quindi dati pubblici, aperti, in tutti i settori che riguardano le politiche pubbliche, dalla sanità alla scuola. Pensiamo al PNRR e ai soldi che il nostro paese dovrà investire nei prossimi anni. I dati completi al momento non sono ancora accessibili, eppure sarebbe fondamentale per giornalisti e cittadini monitorare come saranno usate queste risorse.
Alla prossima Ellissi
Valerio
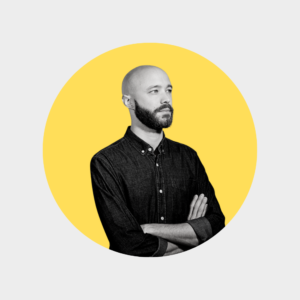 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
LEGGI UN’ALTRA ELLISSI