Cultura Digitale Demotivazionale
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Ti ricordi ancora i demotivational?
Ma sì, dai: quelle composizioni di immagini e testo che prendevano in giro la cultura aziendalista americana e che, alla fine degli anni Novanta, giravano ovunque su forum e chat.
Ecco, tipo questo e questo (o questo, che è il mio preferito).
Benché nati come progetto di un’azienda privata, i demotivational furono uno dei primi meme a diffondersi su larga scala e a diventare un fenomeno culturale di massa.
Migliaia di persone, ai tempi, si cimentarono nella produzione digitale della loro versione dei “poster demotivazionali”, generando mutazioni basate su un linguaggio condiviso — e dando vita a un grande esperimento creativo e, in buona parte, collaborativo.
Questo tipo di processo creativo è per me una delle delle meraviglie del Web, che fin dalla sua nascita ci ha permesso di produrre oggetti culturali spacchettando e riassemblando “pezzi” generati da altri.
Del resto, l’idea che la produzione culturale online debba essere libera di diffondersi, trasformarsi e generare nuove idee – quella che nel 2000 lo statunitense Lawrence Lessig definì remix culture – è alla base della rete stessa.

Umani in servizio
A partire dal 2004, con l’avvento di piattaforme come YouTube e di Facebook, le dinamiche di questa creatività sono però profondamente cambiate: quella che prima era una spinta dal basso scevra da interessi economici è diventata un asset commerciale.
Sulle “piattaforme”, infatti, nessuno può più considerarsi spettatore passivo della filiera culturale: tutte le nostre attività social – persino un like o uno swipe – sono alimento pregiato per gli ingranaggi dativori delle big tech e influenzano, in un modo o nell’altro, la diffusione della cosiddetta “cultura”.
Se da un lato i social ci hanno regalato nuovi strumenti e allargato la platea di produttori/consumatori, è innegabile che dall’altro abbiano contribuito a una standardizzazione della produzione – codificando idee e linguaggi del content – il cui ruolo primario è quello di alimentare modelli di business profondamente sbilanciati verso i detentori dell’infrastruttura.
Bisogna ricordarsi che se le piattaforme cercano continuamente di stimolarci a produrre contenuti, infatti, lo fanno per sfruttare i nostri dati e le nostre azioni: utilizzano una bilancia che pende inevitabilmente non verso i nostri bisogni, ma verso quelli degli inserzionisti.
È un problema, certo: anche perché questo sbilanciamento spinge noi produttori culturali a creare consapevolmente per gli algoritmi, trasformandoci in molti casi in humans as a service – umani al servizio di un’economia che ci mette in competizione gli uni contro gli altri.
Per questo, nonostante le piattaforme si definiscano come forze democratizzanti e si posizionino più come gate-opener che come gate-keeper, e non vogliano essere considerate “editori”, il loro ruolo di filtraggio esiste eccome — e influenza direttamente tutta la produzione, quella digitale come quella analogica.

Verso nuove filiere
Quando, nel 2014, il dizionario americano Merriam-Webster scelse proprio culture come parola dell’anno, ci vide lungo: perché contribuì a mettere al centro la discussione su cosa sia o non sia “cultura” nel digitale.
È chiaro che il termine cultura, anche su internet e nelle sue community, non indichi più soltanto il patrimonio delle conoscenze che formano l’individuo sul piano intellettuale e morale, ma tutti quei set di comportamenti e codici condivisi che utilizziamo per rapportarci alla realtà, e che ci definiscono in base alle nostre azioni digitali.
Quando parliamo di meme culture, di crypto culture, di online culture, di cancel culture, identifichiamo sempre di più delle tendenze che raggruppano le persone attorno a specifici processi produttivi e generativi — del discorso pubblico o dell’oggetto digitale. Anche i Demotivational, nel loro mescolare identità, layer ironici e profitti, erano cultura e produzione allo stesso tempo.
Ma se i codici della produzione culturale diventano essi stessi i termini-valori entro cui si definisce una cultura, non rischiamo che la cultura stessa si appiattisca e diventi sempre più una cultura della produzione? Io credo di sì, e senz’altro le piattaforme hanno avuto un ruolo anche nell’accentuare questo fenomeno.
D’altro canto, oggi, noto sempre meno distinzione tra produzione e diffusione dell’oggetto culturale digitale: sembra che una cosa non possa più esistere senza l’altra. Nei media nessuna esperienza esiste e prospera in un vuoto ed è anche per questo che online, spesso, il formato diventa il messaggio.
Ecco, forse la nostra sfida di domani non sta soltanto nel cercare lo scontro con le corporation che detengono il potere, quanto piuttosto quello di trovare delle alternative: nuovi spazi creativi con regole meno verticistiche e bilance più eque, che siano capaci di garantire una filiera migliore per utenti, produttori culturali e creator.
Al netto del rumore, la conversazione sul web3 sta avendo senz’altro il merito di rimettere al centro del dibattito l’idea di un web in cui le persone possano diventare “azioniste” nella creazione e nella distribuzione del contenuto, e in cui i nostri bisogni si allineino progressivamente a quelli di chi ci fornirà la tecnologia (Substack, sappi che ti tengo d’occhio).
Questo processo, tuttavia, dovrebbe avvenire partendo dall’assunto fondamentale che la cultura le culture digitali – anche quelle che non ci piacciono – siano patrimonio di tutti.
In quanto tali dovrebbero essere libere di svilupparsi e diffondersi senza restrizioni, con la garanzia che chiunque vi partecipi andrebbe, se lo desidera, ricompensato. È una svolta che farebbe bene a noi — e credo anche alle piattaforme.
Alla prossima Ellissi
Valerio
PS. La newsletter di oggi è una rielaborazione della prefazione che ho scritto al libro “Piattaforme digitali e produzione culturale” di Thomas Poell, David B. Nieborg e Brooke Erin Duffy, pubblicato da Minimum Fax.
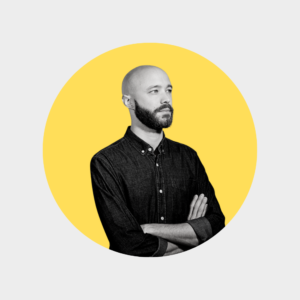 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
