Siamo fatti al 90% di dati. Intervista a Donata Columbro
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
A 62 anni, Stephen Wolfram ha raccolto milioni di dati su un singolo essere umano: se stesso.
L’informatico inglese, fondatore e CEO di Wolfram, ha una personale ossessione per grafici e database.
Dal 1989, infatti, Wolfram tiene traccia di tutti gli aspetti della sua routine quotidiana.
Tra questi ci sono il numero di email spedite e ricevute, i tasti che preme più spesso sulla tastiera del computer, la collocazione oraria media delle sue riunioni quotidiane.
Nel 2012, in un articolo intitolato “The Personal Analytics of My Life”, Wolfram traeva interessanti conclusioni sul proprio approccio al lavoro e al suo processo creativo.
Giusto per capire meglio il personaggio, Wolfram coordina centinaia di dipendenti ogni giorno da casa propria ((ben prima che il termine smart working esistesse).
E lo fa in un modo ancora più particolare: camminando. L’uomo ha infatti fatto montare un tapis roulant sotto la sua scrivania.
Ho ripensato a quel matto di Wolfram qualche giorno fa, leggendo le prime pagine di Ti spiego il dato, un nuovo libro pubblicato da Quinto Quarto edizioni.
L’autrice è Donata Columbro, giornalista esperta di dati e co-fondatrice dell’agenzia Dataninja.
Donata cura anche una rubrica settimanale intitolata Data Storie su La Stampa, ed è docente di Data Visualization allo IULM di Milano.
Nell’introduzione del libro scrive: “Nella prima ora della tua giornata hai già usato elementi di statistica e guardato un grafico per prendere decisioni che ti riguardano”. Ed è vero: oggi produciamo e utilizziamo una quantità di dati notevole, spesso senza nemmeno rendercene conto. Siamo fatti al 90% di dati.
Attraverso aneddoti, curiosità ed esercizi, il saggio – illustrato (benissimo) da Agnese Pagliarini – cerca di spiegarci come funzionano questi dati, ma anche come possiamo “osservarli, raccoglierli, misurarli e capirli” per orientare al meglio le nostre scelte quotidiane.
Siccome i dati sono sempre più centrali nel nostro percorso di comprensione del mondo, e in particolare del mondo post-pandemia, ho pensato di cogliere l’occasione per incontrare Donata e cercare di capirci un po’ di più.
Eccoci, quindi, con una nuova puntata di Ellissi Meets.

{vb} Ciao Donata, grazie di essere qui. Dimmi, anche tu tracci ogni attività della tua vita quotidiana?
{dc} No, ho smesso! L’ho fatto per due anni con un braccialetto di monitoraggio dell’attività fisica e del sonno, prima dell’arrivo di molti smartwatch sul mercato — ma sono troppo performativa, alla fine non mi divertivo più. Adesso se raccolgo dati su qualche aspetto della mia quotidianità lo faccio creando database con oggetti fisici, almeno vado offline ogni tanto.
E come è nato il tuo interesse per il giornalismo dei dati e per la comunicazione visuale? Ci conosciamo da anni e non te l’ho mai chiesto.
Credo sia stato a partire dalla pubblicazione del progetto The Migrant Files, nel 2013, a cura di un network di giornalisti europei tra cui i miei attuali soci di Dataninja Andrea Nelson Mauro e Alessio Cimarelli: per la prima volta qualcuno aveva raccolto e verificato i dati dei naufragi nel Mediterraneo, mettendo insieme diverse fonti giornalistiche e istituzionali e creando il database più affidabile esistente su questo fenomeno. I numeri, spaventosi, che indicavano l’esistenza di un vero e proprio cimitero nel nostro mare, venivano poi visualizzati in tempo reale su una semplice mappa a simboli proporzionali, di grande impatto. Non esistevano ancora le banche dati pubbliche dell’UNCHR o dell’OIM, quindi quel lavoro basato sui dati fu veramente una pietra miliare del data journalism europeo, infatti ricevette diversi premi l’anno successivo.
Come giornalista che si è formata nel mondo della cooperazione internazionale sono rimasta particolarmente colpita dalla potenza di questo lavoro. Nel 2014 ho avuto la fortuna di mettermi alla prova partecipando al percorso di formazione sul data journalism organizzato da La Stampa Academy con Google, formando una squadra con altre giornaliste e designer. Vincemmo il contest finale, con la possibilità di produrre un lavoro data driven per il quotidiano piemontese. Poi ho continuato a collaborare con Dataninja e nel 2019 abbiamo lanciato la prima scuola di formazione sui dati.
La pandemia che stiamo vivendo ha sicuramente contribuito a rimettere i ‘numeri’ al centro del flusso informativo: tu stessa, nel libro, la definisci “l’evento più data-informed della storia”. Puoi spiegarmi che cosa è successo in questi due anni, secondo te, e che impatti quanto accaduto potrebbe avere nel nostro rapporto con i dati sul medio-lungo termine?
È una definizione che abbiamo usato in Dataninja quando ci siamo trovati a intervenire in tantissimi dibattiti pubblici che avevano al centro i dati della pandemia: nessuno di noi ha studiato medicina o ha competenze di epidemiologia, eppure il fatto di lavorare con i dati ci ha fatti diventare un punto di riferimento non per capire l’impatto del virus o delle politiche di contenimento sulla salute delle persone, ma semplicemente per interpretare i grafici che ormai comparivano ovunque, anche in prima serata in tv. Ora ci sembra normale, ma un grafico a linee commentato in un talk show televisivo non era assolutamente frequente prima di marzo 2020.
Ci siamo resi conto che i dati ci riguardano, perché vengono usati dalla politica per prendere decisioni che influenzano la nostra vita quotidiana, anche se ovviamente lo fanno da sempre. Durante un’emergenza sanitaria è diventato molto più evidente. Sul medio lungo termine secondo me è aumentato l’interesse delle persone nel capire percentuali, dati e grafici citati nelle notizie, lo dimostra anche l’enorme seguito dei divulgatori scientifici sui social. Ma aumenta anche l’uso e l’abuso che se ne fa per portare avanti le proprie posizioni. In questo momento circolano grafici e dati interpretati in modo diverso da no vax e pro vax, per fare un esempio.
Negli ultimi anni quasi tutti i giornali hanno introdotto pratiche di data journalism e di data visualization nel loro ciclo di produzione quotidiana. In Italia siamo arrivati a un punto soddisfacente, sotto questo aspetto, oppure resta ancora molto da fare? Come la vedi?
Secondo me la maggior parte delle testate si è resa conto della necessità di avere specialisti nel team o almeno come collaboratori fissi. Manca ancora però “la cultura del dato” trasversale, intesa come l’interesse e la capacità di usare i dati per migliorare la qualità di una notizia. Mi ha colpito il fatto che al Financial Times esista la figura della statistical journalist (che è l’italiana Federica Cocco), cioè la persona che aiuta tutta la redazione a usare correttamente numeri e statistiche nelle notizie. Fare data journalism non vuol dire per forza pubblicare data visualization spettacolari alla New York Times, ma avere una redazione preparata nella lettura, nell’interpretazione e nel racconto del dato.
Il dato è politico, ed è filtrato dai bias: i bias di chi li raccoglie, di chi li analizza, e di chi li interpreta — anche dei lettori, per esempio. Secondo te cosa possiamo fare per sviluppare una migliore conoscenza dei nostri stessi bias e imparare magari a combatterli? Quali strumenti abbiamo a disposizione?
Riconoscere che i bias esistono e che non ne siamo immuni, perché le nostre idee sul mondo dipendono dal contesto in cui siamo cresciuti, dalle nostre esperienze personali, dalla nostra dieta mediatica e dalla bolla di persone che frequentiamo. Secondo me l’unico modo è adottare un atteggiamento curioso, aperto, e farsi moltissime domande davanti a dati e grafici. Le autrici di Data Feminism Catherine D’Ignazio e Lauren Klein propongono di partire dal chi (chi ha raccolto i dati, chi è beneficiato da questa raccolta, chi ne sarà penalizzato); Hans Rosling, divulgatore e medico svedese, in Factfulness suggerisce di tenere a bada la nostra visione iperdrammatica del mondo facendo attenzione a 10 istinti o “megaequivoci” che abbiamo nell’interpretare i dati; Tim Harford in The Data Detective consiglia di mettere da parte i sentimenti, perché anche di fronte ai numeri reagiamo con emotività, l’importante è riconoscerlo.
Secondo i dati OCSE PISA, il 46,3% degli italiani tra i 16 e 65 anni dimostra un livello di analfabetizzazione funzionale piuttosto grave (di livello 1 e livello 2). In pratica si tratta di persone che non sono in grado di comprendere e interpretare correttamente ciò che leggono o che ascoltano. Secondo te la data visualization è un’arma per combattere questo problema, oppure c’è il rischio che possa creare una barriera ancora maggiore? Del resto molte infografiche non sono così semplici da capire.
La penso come l’esperto di infografiche Alberto Cairo: un grafico o una data visualization non sono opere d’arte, vanno lette, esplorate, non ammirate. Questa competenza viene chiamata graphicacy o data literacy ed è come saper parlare una lingua straniera. Bisogna allenarsi a farsi molte domande davanti a una data visualization, altrimenti si rischia di cadere nelle trappole della disinformazione anche in questo campo.
A proposito di Alberto Cairo. In un suo libro di qualche anno fa scriveva che le infografiche erano state usurpate dalle aziende di pubbliche relazioni e dal marketing, e le definiva “poster infantili utilizzati come clickbait”. Anche tu hai notato una deriva simile, un utilizzo commerciale e di facciata del dato per evitare di comunicare ciò che si preferirebbe tenere nascosto?
Sicuramente il data storytelling affascina e che venga usato nel marketing (ma anche nell’attivismo) credo sia normale: ma dipende da noi, da una diffusa incompetenza con i numeri (innumeracy) che blocca ogni pensiero critico o giudizio. In un bel pezzo su The Atlantic i giornalisti responsabili di un database sui dati covid negli Stati Uniti smontano i miti dei dati dicendo che “non sono niente di speciale”, sono solo “un po’ di considerazioni qualitative organizzate in un modo quantitativo”. Messa così, potrebbe aiutarci a essere meno timidi davanti ai dati, anche quelli usati per ingannarci come consumatori.
Nel suo libro “The Laws of Simplicity”, John Maeda dice che “Il segreto della semplicità risiede nel sottrarre ciò che è ovvio e aggiungere ciò che è significativo”. Costruire una buona data visualization significa questo — semplificare e mettere in ordine? Oppure è una visione riduttiva di quella che, orami, è una vera e propria arte?
Dipende sempre dal pubblico a cui ci rivolgiamo e al nostro obiettivo. Sempre in Data Feminism le autrici mettono in guardia sul minimalismo delle data visualization perché il rigore associato ai grafici e ai numeri potrebbe alimentare il loro potere dis-informativo. In realtà nessun grafico è imparziale, l’autore o l’autrice hanno sempre un interesse o un obiettivo. Il più importante e condiviso credo possa essere quello di mettere il pubblico nelle migliori condizioni di capire la notizia. In alcuni casi sarà meglio semplificare, in altri invece anche organizzare installazioni fisiche di dati, magari partecipative, in luoghi pubblici, per far toccare, percepire e ricordare meglio i dati che vogliamo raccontare.
Guardando al futuro. In quali aree del giornalismo pensi che i dati possano rivestire un ruolo più importante nel migliorare la nostra comprensione del mondo? Dove c’è più spazio e dove più necessità dell’intervento dei dati?
Come dicevo prima, più che dell’intervento dei dati servirebbe più data literacy nelle redazioni e anche tra i lettori. In ogni caso sicuramente servirebbero più dati, e quindi dati pubblici, aperti, in tutti i settori che riguardano le politiche pubbliche, dalla sanità alla scuola. Pensiamo al PNRR e ai soldi che il nostro paese dovrà investire nei prossimi anni. I dati completi al momento non sono ancora accessibili, eppure sarebbe fondamentale per giornalisti e cittadini monitorare come saranno usate queste risorse.
Alla prossima Ellissi
Valerio
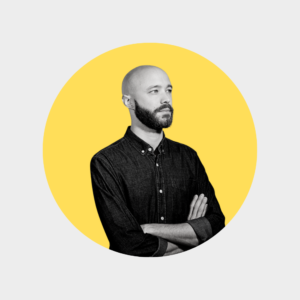 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
