Lo “spacchettamento” dei media
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
“Costruiamo velivoli che connettono le persone, ma questo non ci rende una compagnia aereospaziale”.
Nel 2018, Mark Zuckerberg rispose così ai senatori del Congresso americano che gli chiedevano se Facebook fosse (oppure no) una media company.
Una risposta caustica che serviva per eludere un’altra domanda, ben più spinosa: i social network sono responsabili del contenuto che ospitano e distribuiscono?
Per quanto mi riguarda, possiamo considerare superata la questione. I tempi cambiano, siamo già entrati in una nuova era.
Le piattaforme oggi non sono più soltanto media company, ma creator company.
Da Facebook a Twitter, da Spotify a TikTok, le maggiori aziende tech si stanno dotando di un’infrastruttura che permette a ogni creator di monetizzare con semplicità i propri contenuti.
Questo grafico di Axios spiega bene l’evoluzione della situazione.
Per giornali e piattaforme è l’inizio di una nuova battaglia. Non più incentrata sulla pubblicità, stavolta, ma sulle persone — che sfruttano strumenti tecnologici sempre più accessibili per mettersi in proprio.
{Come teorizzava l’economista francese Jean-Baptiste Say, anche in questo caso, l’offerta genera la domanda.}
Nei prossimi anni vedremo sempre più giornalisti e creator lasciare le testate di appartenenza per mettersi in proprio: autrici e autori in cerca di maggiore libertà, minore dipendenza dalle dinamiche redazionali, e uno stipendio più alto.
È una guerra dei talenti, come scrivevo qualche settimana fa, in cui i media tradizionali sono magneti sempre meno potenti. Un tornado che sta iniziando a fare capolino anche in Italia.
Jessica Lessin lo ha definito un riallineamento di capitale umano che, secondo lei, “distruggerà molte testate e avvantaggerà quelli abbastanza intelligenti da capire come approfittarne”.
Sul tema Lessin è in prima linea, e non da ieri: la testata che ha fondato e dirige, The Information, è stata la prima ad assumere un corrispondente dedicato esclusivamente alla creator economy.
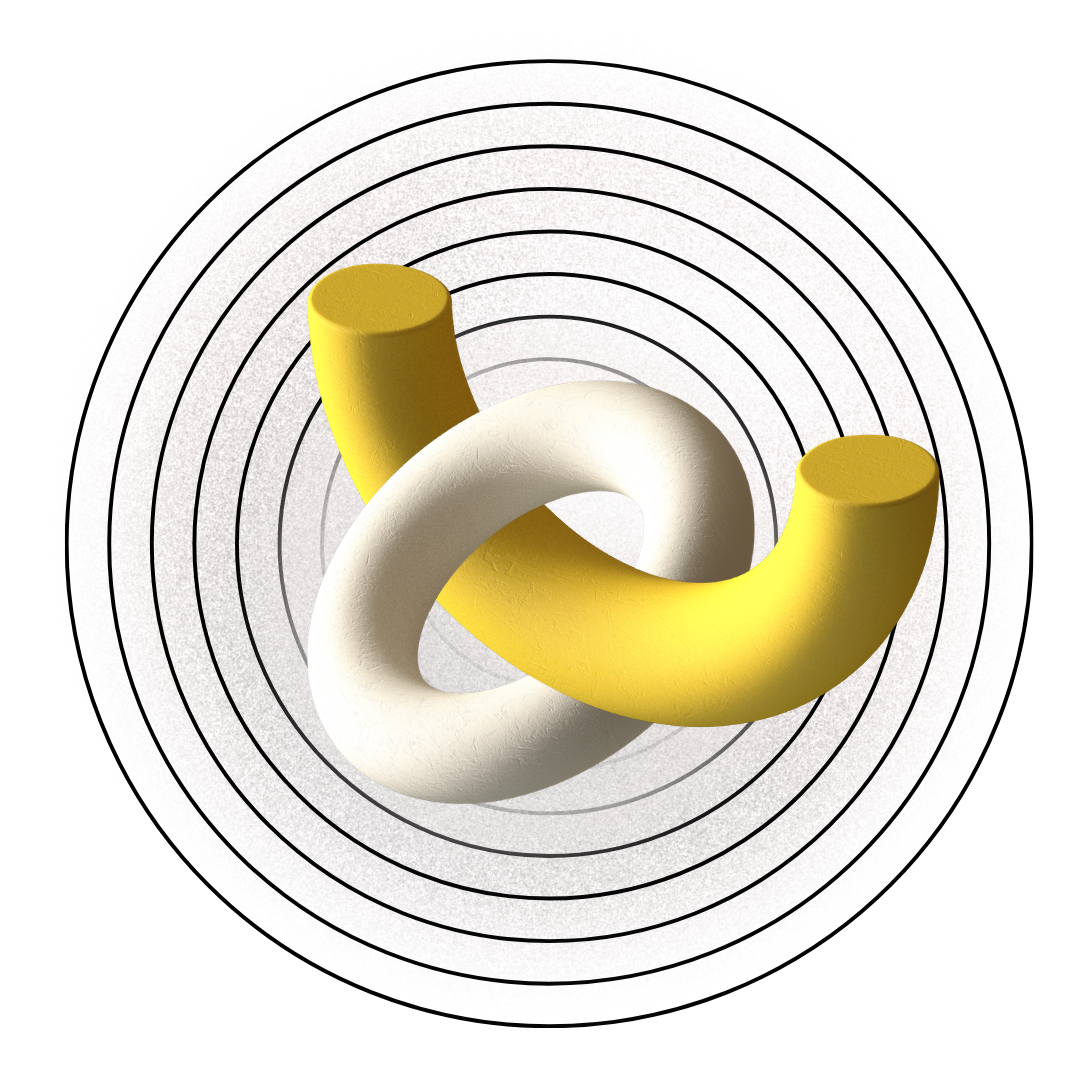
Cos’è una media company, oggi?
Non so tu, ma nella mia attuale dieta mediatica ci sono sempre più newsletter, podcast e pubblicazioni di nicchia create da autori indipendenti, veri e propri microimprenditori del contenuto.
Firme che seguo e che, in qualche caso, finanzio attraverso subscription e membership.
E qui veniamo al problema principale. Le testate rischiano di perdere non solo le loro penne più valide, iconiche e rappresentative, ma anche quelle in grado di attrarre più abbonati — dove c’è following e un forte brand personale, c’è un driver efficace di conversione.
In fondo, ogni media company è soprattutto una talent company.
Questa diaspora del talento ha anche un altro effetto, tutt’altro che secondario.
Parlo del progressivo spacchettamento dei media tradizionali, il tanto chiacchierato unbundling.
Cambiano le dinamiche, diminuiscono gli intermediari, si trasformano le infrastrutture di costo: la forma tradizionale delle testate-azienda viene messo in discussione.
Nel nuovo mondo i contenuti viaggiano su Substack o Mailchimp o Revue, il marketing avviene su Instagram, la discussione su Twitch o Discord, il networking su Clubhouse e LinkedIn e la monetizzazione via Pico o Stripe: le funzioni di interi dipartimenti, che esistevano in relazione tra loro nelle società editrici, non sembrano più indispensabili come un tempo.
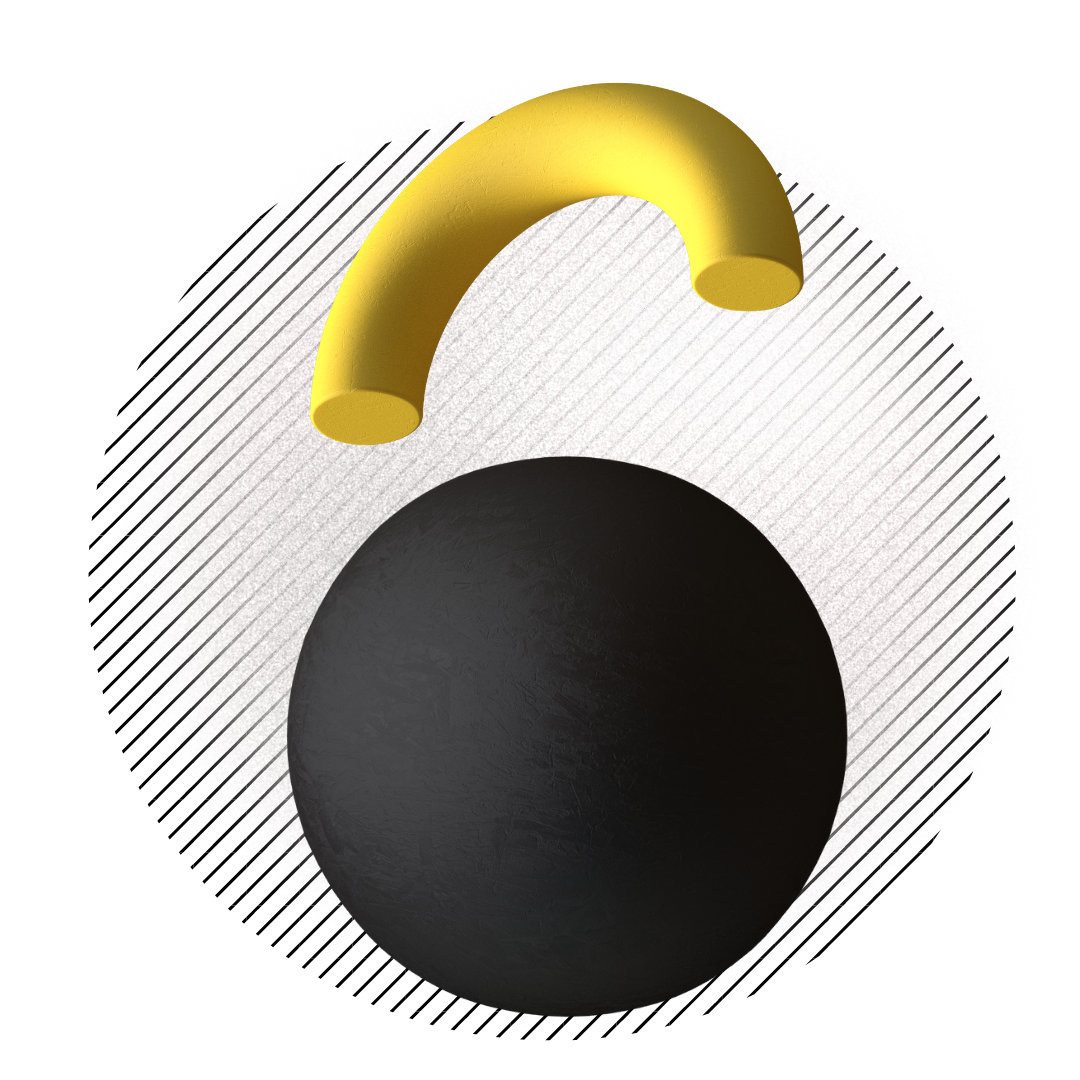
Che cosa succede ora?
Siamo in quella che Simon Owens ha definito la fase 1 dell’unbundling, basata sulla forza dirompente delle iniziative individuali di tanti creator.
Ma stiamo già vedendo i primi esperimenti da fase 2, costituita da un re-bundling verso nuovi modelli.
Un esempio di questo trend sono i collettivi e le testate formate da giornalisti che agiscono nella doppia veste di proprietari, alleati tra loro per condividere e ammortizzare centri di costo (marketing, editing) e creare un effetto network in grado di trainare i pubblici verso l’acquisto di un bundle.
Parlo di progetti come Every.to (newsletter company ad abbonamento unico fondata da 6 ex-Substacker), o Defector (un superblog collettivo a tema sportivo lanciato dagli ex redattori di Deadspin).
Un approccio simile, anche se diverso a livello di obiettivi, è Sidechannel, un canale Discord in cui otto autori di newsletter molto seguite – ci sono Casey Newton e Delia Cai, per dirne due – organizzano discussioni periodiche riservate ai loro iscritti, invitando anche degli ospiti.
{Il primo ad accettare, guarda caso, è stato proprio Mark Zuckerberg}.
A questo scenario in trasformazione si aggiungono i DAO, organizzazioni trasparenti e decentralizzate basate sulla Ethereum blockchain: in pratica, associazioni digitali di cui nessun membro è proprietario, e in cui tutti i partecipanti sono nodi di una catena vincolati da uno smart contract.
I DAO stanno iniziando a diffondersi anche nel mondo dei media.
Come reagiranno i media tradizionali?
Le prime mosse paiono piuttosto attendiste: il New York Times e la sua policy sui side project ne è un esempio.
Se vogliono prevenire il problema, le testate tradizionali devono pianificare le proprie mosse per tempo: dando più visibilità alle firme, nutrendo internamente la loro voglia di indipendenza e possibilmente – tasto dolente, questo – aumentandogli lo stipendio.
Recentemente, Forbes ha annunciato un programma dedicato ai ‘giornalisti imprenditori’ che gli offre la possibilità di lanciare newsletter verticali senza uscire dal cappello del brand. In cambio questi giornalisti ottengono soldi, formazione, e una percentuale sugli abbonamenti generati.
Il Telegraph sta lavorando a un contestato piano di incentivi per remunerare i giornalisti che generano più subscriber.
A un modello simile sta pensando anche Jon Kelly con la sua nuova società, un Vanity Fair per l’era di Substack.
Qualunque sia la strada, è evidente la necessità di un radicale ripensamento delle metriche attraverso cui i media misurano le proprie performance e quelle dei propri giornalisti.
Serviranno analisi dati e tecnologie più granulari, non solo per comprendere meglio quali anelli della catena del valore siano più importanti, ma anche per riuscire a paragonare le performance dei creator nelle testate con quelli delle piattaforme (sarà dura).
L’importante, credo, sia non cercare di fare finta di niente.
La tentazione di lasciar passare la tempesta e aspettare che la mandria rientri al pascolo è forte: il rischio però è quello di ritrovarsi con sempre meno vacche, e sempre più magre.
Come ha scritto Brian Morrissey su The Rebooting, “quelli che lo etichettano come un trend passeggero mi ricordano quelli che, nei primi anni 2000, pensavano che i blogger fossero dei ragazzini ancora a casa dei genitori, la maglietta sporca di pizza e un bisogno disperato di vitamina D. Il modo in cui le cose cominciano non è lo stesso modo in cui vanno a finire”.
Valerio
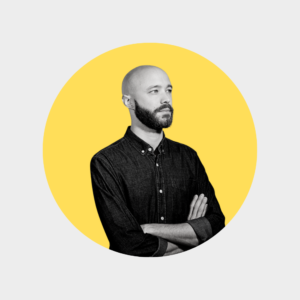 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
