La guerra dei talenti: chi offre di più?
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Quanto stigma c’era quindici anni fa verso chi cercava di costruirsi una carriera pubblicando su internet?
Gli autori di libri in self-publishing erano degli “sfigati”. I blogger “giornalisti che non ce l’avevano fatta”. I divulgatori di scienza e tecnologia su YouTube degli “emarginati sociali” — tipi che, quando li incrociavi in paese, cambiavi marciapiede.
Qualsiasi autore era obbligato ad ottenere una sorta di certificazione istituzionale – fosse quella di una grande testata giornalistica, di una casa editrice, di una radio o di una televisione – prima di poter essere preso sul serio dal pubblico.
Allora, essere accolti dalle braccia di una parent company significava ricevere un bollino irrevocabile di qualità e credibilità.
Internet e i social, allo stesso tempo, erano considerati alla stregua di un parco giochi, o al massimo di uno (scivolosissimo) terreno di addestramento. Il do it yourself era visto come un hobby e non come una carriera.
Nell’era della sfiducia in cui viviamo, invece, il paradigma si è quasi ribaltato.
Oggi chi fa da solo è più credibile proprio perché non dispone di una struttura che lo sorregge: non deve rispondere a interessi diversi da quelli del suo pubblico.
Il rapporto uno-a-uno che il creator è in grado di stabilire con il proprio pubblico è garanzia automatica di trasparenza.
Il perché è evidente: la fiducia, che è il motore immobile di ogni relazione (anche digitale), non ha un costo di acquisizione — si può solo costruire un pezzo alla volta, con tenacia, intelligenza e qualità. E questo gli utenti lo capiscono benissimo.
Così, oggi l’economia della relazione è diventata uno dei cardini del digitale.

Cosa è cambiato in questi anni?
Primo, le nicchie non sono più considerate come un angolo noioso e strambo di internet, ma come nodi di un network di valore.
Tutti oggi sanno che le community piccole generano interazioni di qualità superiore a quelle mainstream.
In molti hanno appreso – spesso sulla propria pelle – quanto sia più facile costruire credibilità quando si è ancora ‘piccoli’, piuttosto che quando si è CCO di una multinazionale.
Secondo, oggi i creator hanno a disposizione una miriade di nuovi strumenti costruire e monetizzare la propria individualità: l’accesso alla micro-imprenditorialità creativa si è democratizzato.
Il che ha tagliato fuori molti intermediari, con i pro e contro che questo comporta.
Il passaggio dall’economia dell’attenzione all’economia della relazione ha spostato l’obiettivo dalla ‘reach a ogni costo’, dall’obbligo di raggiungere i grandi numeri, alla misurazione della qualità del rapporto instaurato con la propria audience.
Questo ribaltamento è evidente anche in un altro meccanismo:
• Nel mondo di prima le piattaforme (o le case editrici, o le televisioni) erano i trampolini che permettevano ai creator di raggiungere un pubblico altrimenti inaccessibile;
• Nel mondo di oggi, il creator è la leva attraverso cui le piattaforme (o le case editrici, o le televisioni) agganciano nuovi pubblici e guadagnano credibilità.
Se prima ai creator finiva in media il 15% degli introiti generati dai propri contenuti sulla piattaforma, oggi è vero il contrario: le piattaforme trattengono il 15% dei guadagni dei creator, lasciandogli il resto.
Questo è, secondo me, un power shift epocale. E ha aperto uno scenario completamente nuovo: quello della guerra dei talenti.
Oggi le piattaforme sanno di aver bisogno di contenuti esclusivi e della relazione credibile che questi creator hanno con le proprie audience — e sono disposte a pagare per assicurarseli.
Per questo hanno un nuovo obiettivo (metafora calcistica alert): convincere i prossimi Mbappé a indossare la loro casacca e non quella di una squadra concorrente.
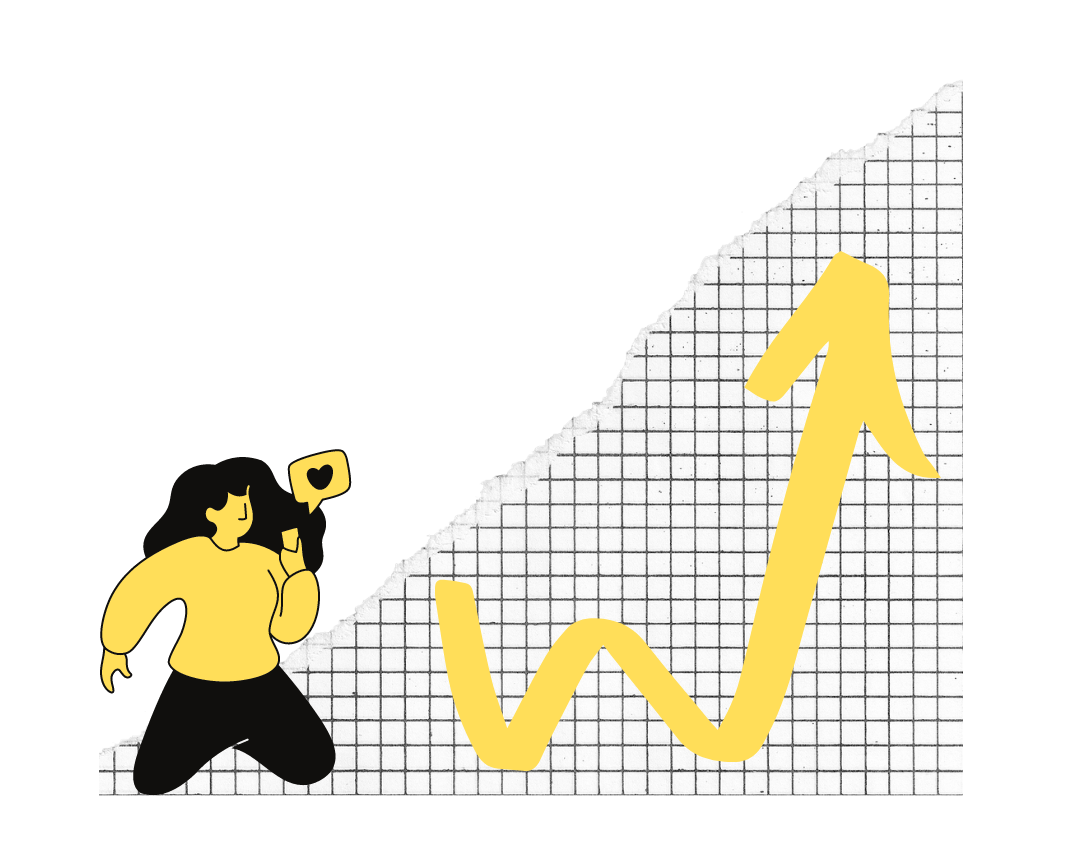
Chi partecipa a questo calciomercato digitale?
Tutti, più o meno.
Spotify e Audible sono già da tempo in campagna acquisti nel mondo dell’audio, con investimenti vertiginosi.
Le piattaforme di online gaming, come Twitch, la (defunta) Mixer e Facebook Gaming hanno un’idea molto chiara di quanto valga uno streamer di punta: tantissimo.
Nel 2020, TikTok ha aperto un fondo da 200 milioni per finanziare i migliori tiktoker, assicurando che la cifra quintuplicherà in un triennio.
Snapchat afferma di versare già un milione al giorno ai propri creator.
Alla contesa si sono aggiunte recentemente anche Facebook – che sta testando una sua piattaforma di newsletter con autori selezionati – e Twitter, dopo l’acquisizione di Revue.
Anche Medium, il ‘superblog’ fondato da Ev Williams, ha annunciato in questi giorni che dismetterà il proprio team editoriale interno e le nove testate lanciate tra grandi fanfare nel 2019, per investire di più sui blogger indipendenti che popolano la piattaforma, sostenendo direttamente il loro lavoro.
Nessuno è immune a questa tendenza. Nemmeno Substack che, come si è scoperto da poco, elargisce anticipi, salari e benefit di vario genere per convincere alcuni giornalisti affermati a pubblicare al suo interno.
Le piattaforme insomma sanno benissimo che senza la forza, il talento e le audience dei loro creator – i loro superutenti – il loro valore diminuirebbe rapidamente.
Yoav Arnstein, Director of Product Management a Facebook, ha spiegato che i produttori di contenuto è “assolutamente fondamentale” per le piattaforme di social media.
Facebook sa benissimo che la credibilità non può essere ‘copiata e incollata’, a differenza delle funzionalità di una concorrente.
La dinamica interessante di questa guerra è che gli investimenti non sono più destinati soltanto a una cerchia ristretta di top influencer, ma possono arrivare anche ai creator emergenti, ai più promettenti tra i ‘piccoli’, patrimonio del futuro.
Si sta scatenando, insomma, una gara globale all’acquisizione del talento. Dove, immagino, vincerà chi offre di più, ma anche chi sa meglio cosa vuole.
Forse siamo davanti alla definitiva caduta del velo che avvolgeva il ritornello, ormai quasi ancestrale, del “we are a tech company, not a media company”.
Chi vince? E chi perde?
A vincere saranno soprattutto alcuni creator indipendenti, che si vedranno recapitare offerte economiche allettanti per trasferire i loro contenuti (e la relazione con il loro pubblico) in esclusiva su queste piattaforme.
A perdere, invece, saranno i giornali. Al momento infatti il mondo dell’informazione non ha la potenza di fuoco per combattere questa battaglia ad armi pari.
I giornali sono spesso realtà pachidermiche, e difficilmente riusciranno a offrire la flessibilità e la remunerazione adeguata per assicurarsi i migliori creator (né per portare a bordo giornalisti giovani, ma questa è un’altra storia).
Già nel 2008, nel suo seminale saggio 1,000 True Fans, Kevin Kelly evidenziava il problema:
“Now here’s the thing; the big corporations, the intermediates, the commercial producers, are all under-equipped and ill suited to connect with these thousand true fans. They are institutionally unable to find and deliver niche audiences and consumers.”
Anche in questo campo, nessuno è immune. Persino il New York Times, senza dubbio il giornale con più appeal al mondo, ha da poco varato una nuova policy aziendale che costringe i giornalisti interessati a lanciare un proprio side project – una newsletter su Substack, per esempio – a ottenere l’approvazione di un comitato interno.
È più plausibile che i giornali stessi vengano considerati ‘creator’ di contenuti dalla piattaforme e pagati come tali (il recente caso legato a Google Showcase ne è un esempio).
Strade alternative – come quella del Daily Telegraph, che sta pensando di pagare i propri giornalisti in base al traffico e agli abbonamenti generati – mi sembrano deleterie.
Tu che ne pensi?
Valerio
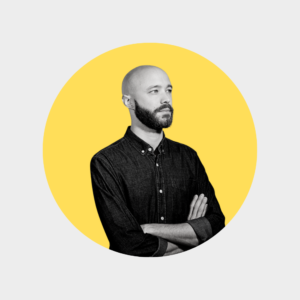 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
