Viviamo in una perenne versione beta
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Quel giorno l’azienda rimosse l’etichetta ‘beta’ dal logo di Gmail, il suo servizio di posta elettronica, che era stato lanciato cinque anni prima, nel 2004.
Una scelta che – almeno in teoria – annunciava come la fase della sperimentazione del software fosse finalmente giunta a conclusione dopo cinque lunghi anni.
Ma di norma le fasi beta durano mesi, non anni. E non sono utilizzate da milioni di utenti.
Per questa ragione, la versione ‘provvisoria’ di Gmail era diventata quasi un cult — oggetto di conversazione tra appassionati ed esperti nei forum digitali, che faticavano a spiegarsi una fase di test così prolungata.
Negli uffici di Mountain View, però, tirava tutt’altra aria: rimuovere l’etichetta non significava affatto che il prodotto-Gmail fosse concluso.
La scelta era stata presa solamente perché alcune grandi aziende, interessate ad acquistare il servizio di posta elettronica per i propri dipendenti, non si fidavano a investire su un prodotto ancora ufficialmente in fase beta.
A spiegarlo – con una certa dose di ironia – fu la stessa Google, in un post pubblicato sul suo blog ufficiale:
“Ci chiedono spesso perché così tante applicazioni di Google restino perennemente in beta. Gmail, per esempio, ha indossato l’etichetta ‘beta’ per più di cinque anni. Comprendiamo che la situazione sia di difficile comprensione per alcune persone, soprattutto coloro che pensano che un software in beta non sia pronto per essere utilizzato dal grande pubblico. L’etichetta beta non si adatta bene alle grandi imprese, restie a far girare il proprio business su software che suonano come se fossero ancora in una fase di test”.
L’azienda annunciò anche che qualsiasi utente – nel caso ne sentisse la mancanza – avrebbe potuto ripristinare l’etichetta in un click, attraverso il menu delle impostazioni. Lol.
Il messaggio di Google al mercato, insomma, era chiaro: non bisogna più considerare la beta come una fase di passaggio, ma come una condizione costante di un servizio, che non finisce certo con la rimozione di un’etichetta da un logo.
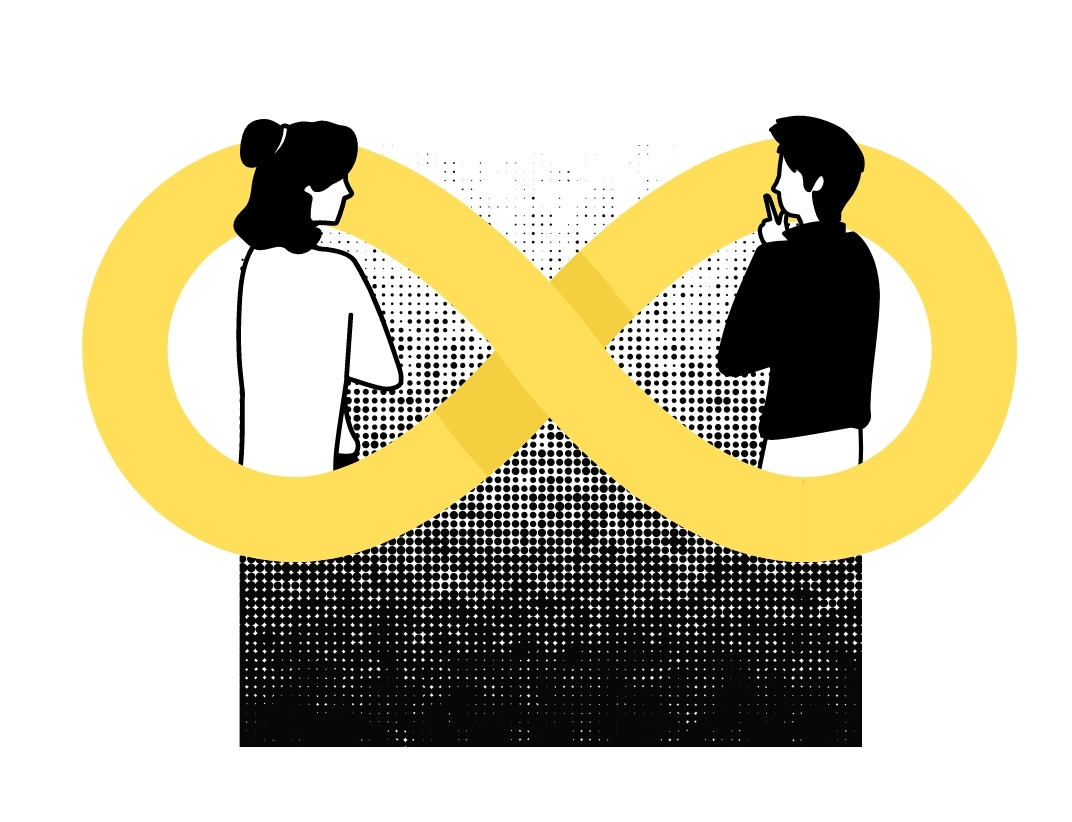
È cambiato qualcosa da allora?
Sì, quasi tutto.
In primis, sono cambiati i processi. La metodologia agile ha trasformato il modo in cui vengono creati i software: gli sviluppatori lavorano seguendo un ritmo a cicli brevi – di solito una o due settimane – al termine dei quali nuove funzioni o correzioni vengono rilasciate al pubblico.
È il motivo per cui, every bloody Sunday, molte delle app sul tuo telefono chiedono di essere aggiornate.
Inoltre sono cambiati radicalmente anche i modelli di business: la subscription economy ha portato un modo nuovo di guardare al mercato, in cui la metrica regina non è più il numero di unità vendute, ma il valore economico generato da ogni cliente nel corso del tempo.
Il nuovo modello ha diffuso la consapevolezza che il prodotto non è mai finito, ma evolve costantemente, adattandosi in modo incrementale ai feedback e ai comportamenti di utilizzo dei suoi utenti.
Adobe, una delle case di produzione software più grandi al mondo, è un esempio di questo cambio di paradigma.
Fino al 2010 chi voleva utilizzare Photoshop, uno dei programmi più conosciuti di Adobe, doveva spendere 600 dollari per acquistare un cd-rom che conteneva la versione più recente del software.
Ogni anno e mezzo circa, poi, una nuova release del programma veniva immessa sul mercato, con nuove funzionalità e miglioramenti; ciclicamente l’azienda aveva dunque la missione di convincere quanti più utenti possibili della bontà del nuovo prodotto, spingendoli a ripetere l’acquisto.
Ma il modello si stava dimostrando sempre più fragile: il numero di unità di Photoshop vendute non cresceva (anzi, diminuiva) e così l’unico modo per innalzare le revenue era quello di aumentare il prezzo del software, causando non pochi mugugni tra gli utilizzatori più affezionati.
Fino al 2011, quando l’azienda stravolse il proprio modello di business e divenne una delle prime software house a testare la strada delle subscription: ora l’utente poteva abbonarsi in cloud al pacchetto creativo di Adobe – che includeva altri programmi oltre a Photoshop – e con una spesa mensile più contenuta era certa di possedere sempre la versione più recente del programma.
Fu una svolta storica. Superato lo scetticismo iniziale degli investitori il modello si dimostrò vincente (e decisamente più remunerativo), diventando lo standard di mercato.
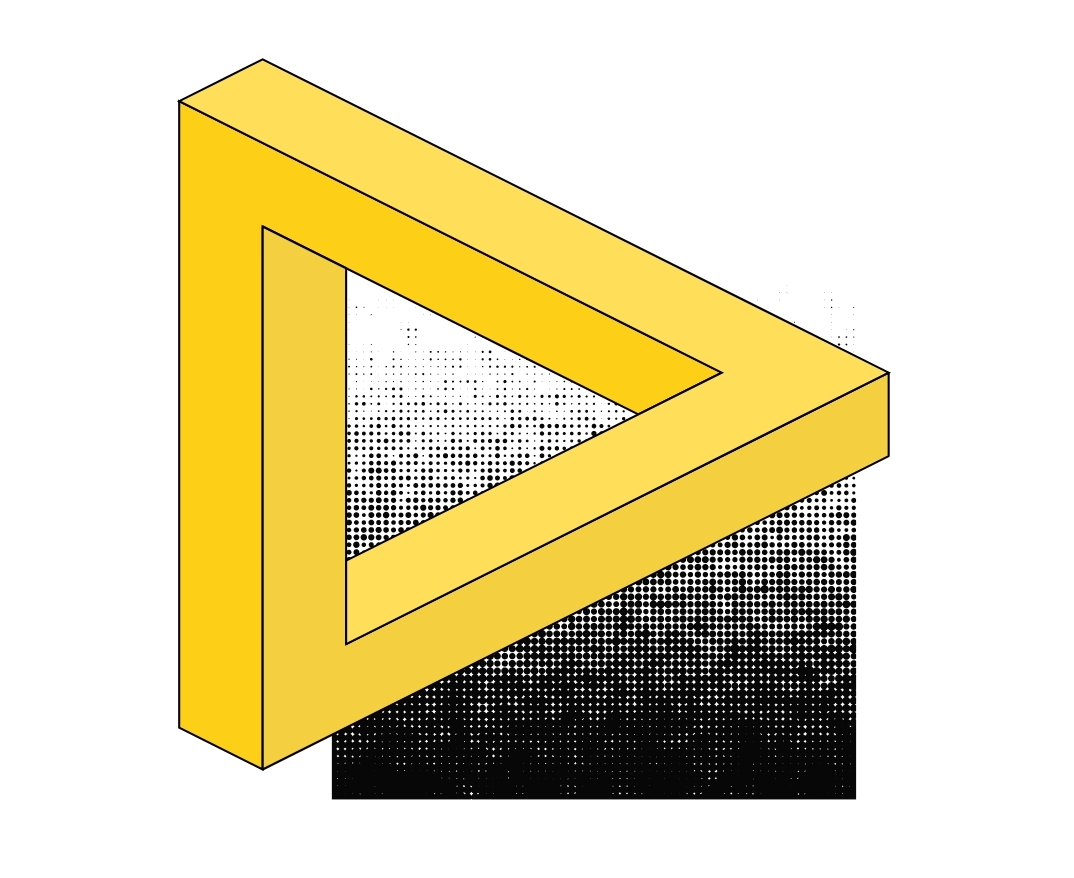
Che effetto ha questo nuovo paradigma sulle aziende?
Da un lato, come spiega Tien Tzuo in Subscribed, da cui ho scoperto anche la storia su Gmail, il modello ad abbonamento permette alle aziende di poter contare su entrate ricorrenti. Il primo gennaio di ogni anno le società che utilizzano le subscription riescono a prevedere con ragionevole certezza le entrate dei successivi dodici mesi.
Inoltre, queste aziende riescono a sfruttare al massimo livello la beta perpetua: finalmente in grado di osservare l’utilizzo del prodotto da parte degli utenti in cloud, possono raccogliere feedback periodici e migliorare progressivamente il servizio che offrono — coltivando una relazione più continuativa e fidelizzata che mai con la propria clientela.
C’è un concetto giapponese che ben esemplifica questo approccio: è il kaizen (traducibile come “miglioramento continuativo”), nato nelle sezioni ricerca e sviluppo di Toyota negli anni ’80. Il kaizen è l’idea che rinnovarsi a piccoli passi sia meglio che affidarsi a grandi leap di innovazione. È un approccio più sostenibile e, alla lunga, anche più lucrativo.
Per tutte queste ragioni oggi prodotti, servizi ed esperienze non sono mai “finiti”, e vengono offerti sempre più in uno stato di beta perpetua.
È un nuovo mondo as a service, in cui sviluppiamo relazioni più a lungo termine con i brand, persino quelli che offrono prodotti fisici: oggi puoi abbonarti a un telefono, a un’automobile, a un paio di scarpe per i tuoi figli, a una cassetta di frutta e verdura.
E noi, come stiamo cambiando?
Mentre più prodotti e servizi diventano bete perpetue, noi ci trasformiamo in instancabili beta tester: tutte le nostre azioni e le nostre interazioni, oggi, sono parte integrante dei processi di miglioramento dei prodotti che utilizziamo.
Seppur lentamente, questo approccio sta diventando sempre più centrale anche nel mondo dei media, in cui lavoro.
Subscription digitali e programmi di membership ‘costringono’ i giornali a portare i lettori al centro della produzione, considerando i loro bisogni e le loro idee nelle decisioni editoriali e di prodotto.
Essere più customer-centric sta facendo benissimo al giornalismo, un’industria in cui storicamente i feedback dei lettori arrivavano prima all’edicolante (o al barista) che al direttore.
Ma c’è ancora tanto lavoro da fare, credo. Soprattutto sui formati statici con cui veicoliamo le informazioni – il giornale, l’articolo – che passano dal prototipo al rilascio sul mercato senza mai transitare da una versione beta. Paradossale, visto che il loro compito è quello di raccontare una realtà in continua e progressiva evoluzione.
Io credo che il ruolo del giornalismo, nell’era della subscription economy, dovrebbe essere quello di offrire ai lettori l’accesso a un piano ciclico di manutenzione per la mente, un upgrade alla volta.
Su questo tema potrei tediarti ancora a lungo, ma concludo.
Se c’è qualcosa ci ha insegnato il 2020 è che le sfide del presente cambiano continuamente. Per questa ragione, non ha senso che i prodotti incaricati di aiutarci a risolverle siano immutabili.
Ti chiedo, quindi: stai mettendo abbastanza kaizen in quello che fai?
Valerio
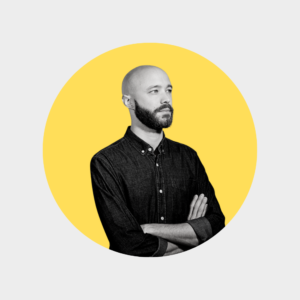 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
