La lezione di Quibi
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Oggi ti parlo di Quibi.
Ho voluto aspettare che sedimentasse un po’ il chiacchiericcio web prima di parlarne; ma recupero volentieri, visto che è una storia da cui possiamo imparare qualcosa di utile.
Prima di arrivare all’epilogo, gradirei un riepilogo.
Senz’altro: cominciamo dall’inizio. Cos’è Quibi?
Quibi era – uso il passato, poi ti spiego perché – un nuovo servizio di streaming di contenuti originali on demand, lanciato nell’aprile di quest’anno, tra grandi attese e altrettanto poderosi investimenti (quasi! due! miliardi! di! dollari!).
Con quei soldi l’azienda aveva iniziato a reclutare mezza Hollywood: Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Kevin Hart, Naomi Watts, Chance the Rapper, Cara Delevigne, Jennifer Lopez, a colpi di contratti milionari. Quibi aveva infatti la fama di pagare tantissimo per le sue produzioni (fino a 125mila dollari al minuto, quando la media dell’industria si assesta a 10mila.

Jeffrey Katzenberg, fondatore di Quibi.
E allora, che fai?
Ma Quibi non voleva fare concorrenza ad altre piattaforme di streaming solamente grazie alla qualità dei suoi contenuti.
L’azienda faceva leva su una visione mobile-only dell’intrattenimento: i suoi contenuti erano infatti fruibili esclusivamente via smartphone ed erano suddivisi in piccoli chunk da 10 minuti — “pezzetti” di intrattenimento da consumare mentre si è in metropolitana, o in attesa di un caffè da Starbucks.
Un servizio di video on demand creato non tanto per il divano e il dopocena, quindi, quanto piuttosto per il resto della giornata, da fruire principalmente in mobilità.
A supporto della sua idea di un intrattenimento a piccoli morsi, Quibi (breve per “quick bites”) aveva sviluppato una tecnologia – chiamata Turnstyle – che permetteva all’utente di cambiare in qualsiasi momento l’orientamento del proprio telefono e di poter continuare a fruire il video con una prospettiva narrativa sempre ottimale (funzionava così) sia in modalità landscape che portrait.
Le riprese e il montaggio dei film e delle serie di Quibi erano infatti stati realizzati dai registi tenendo a mente le possibilità offerte da questa tecnologia.
Nulla di tutto questo sopravviverà alla pandemia, comunque. Il motivo per cui ne parlo al passato è che Quibi ha annunciato che chiuderà i battenti alla fine di questo mese.
Che non tirasse una grande aria si era intuito già a luglio, quando era girata la voce che il 90% degli utenti di Quibi non avesse rinnovato il proprio abbonamento al termine del periodo di prova gratuita.
Se lavori in un subscription business di qualsiasi tipo, sai già che un tasso di conversione del 10% non è un buon segno.
Perché Quibi non è arrivata nemmeno al secondo lockdown?
I motivi sono diversi, e tra questi c’è sicuramente la pandemia (non è facile proporre un servizio da usare in mobilità, quando la mobilità di fatto non è più permessa).
Evidenzio però tre ulteriori problemi — più rilevanti, almeno credo, per i lettori di Ellissi.
Il primo. Quibi ha sempre negato che il suo concorrente primario fosse Netflix, ma in realtà era vero il contrario: l’azienda puntava a una viewership molto simile a quella della piattaforma di Reed Hastings. Allo stesso tempo, però, il formato dei “quick bites” la esponeva a un altro parco di tostissimi competitor, come TikTok, Instagram e YouTube, piattaforme che già si spartiscono quasi tutta l’attenzione online dedicata ai video short form. Video che, per di più, sono gratis.
Il secondo. La tecnologia Turnstyle, di cui ti ho parlato prima, era una bella scusa per attrarre investitori, ma non rispondeva a un reale bisogno degli utenti. Era una feature, ma veniva venduta come un product value.
Il terzo. Quibi si è confinata da sola in una gabbia tecnologica: innamorata e fiera del suo essere mobile-only, Quibi all’inizio permetteva di fruire i contenuti solamente da telefono; salvo poi introdurre, tardivamente e goffamente, la possibilità di effettuare trasmissioni in chromecast anche su schermi più grandi.

In foto: un abbonato a Quibi.
Che possiamo imparare da questa vicenda?
Che la si guardi in modalità landscape o portait, la breve storia di Quibi è esemplificativa di un errore molto comune: quello di confondere un cooler product con un better product. Non sempre, però, ciò che è più fico è anche migliore.
Quibi era convinta che la sua visione tecnologica sarebbe stata sufficiente per costruirsi un mercato, ma alla base di questo ragionamento c’era un misunderstanding, e cioè che al pubblico non piace guardare film o serie tv dai propri smartphone, a meno che non sia l’unica soluzione possibile in una data situazione (ad esempio, durante un viaggio in treno).
Quella di Quibi somiglia un po’ alla catarsi finale delle tragedie greche, in cui la caduta dell’eroe tragico permette al pubblico di trarre un insegnamento. La fine di un singolo che porta beneficio alla collettività.
Nella sua hybris tipicamente hollywoodiana, Quibi ha voluto sfidare gli dei dell’attention economy e, presa dall’ebbrezza, ha volato troppo vicino al sole: le ali di cera hanno iniziato a sciogliersi ancora prima di prendere quota.
Ci sono altri esempi simili?
Eh, centinaia. Anche nell’informazione e nei media.
Il fallimento di Quibi mi ha riportato alla mente un altro fallimento spettacolare: quello di The Daily, il magazine solo per iPad, lanciato da Murdoch nel 2011 e chiuso appena un anno dopo.
Il giornale veniva aggiornato ogni mattina e restava online per 24 ore, per poi venire sostituito dall’edizione successiva — ma il progetto era soprattutto figlio di un’infatuazione, ovvero quella del magnate australiano dei media per il tablet ideato da Steve Jobs, più che da un’idea di business radicata in un bisogno reale degli utenti.
{Ti ricordo, a onor di cronaca, che Jobs non permetteva ai suoi figli di utilizzare l’iPad. E ho detto tutto.}
A volte i prodotti che sono cooler, ma non better, non forniscono un’alternativa migliore a quello che esiste già sul mercato.
La tecnologia ha senso solo quando è un abilitatore, ovvero quando offre possibilità radicalmente nuove.
Ti ricordi la defunta app di Quartz? A quanto pare non erano poi così tante le persone interessate a “chattare con le news”.
L’importante è prendere cautionary tales come quello di Quibi e farne tesoro. Un po’ come nelle rappresentazioni di Eschilo, appunto, dove la tragedia aveva lo scopo di elevare la collettività.
Come scrive Taleb in Antifragile, i fallimenti di un singolo hanno senso quando diventano fonte di antifragilità per tutti gli altri; le informazioni più preziose che possiamo trarre da storie come questa, dunque, sono relative a ciò che non funziona, a come non fare le cose.
C’è una tensione costante tra l’io e il noi, ed è sempre qualcuno a pagare il prezzo affinché l’intero sistema migliori — la fragilità che porta a un fallimento, insomma, rafforza l’antifragilità del sistema.
Chiariamoci. Come scrive Taleb, sbagliare è fondamentale: l’importante è compiere tanti errori diversi, ma mai due volte lo stesso.
Valerio
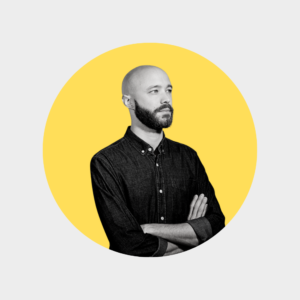 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
