Le migliori menti
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Disse anni fa un ex ingegnere di Facebook: “Le migliori menti della mia generazione stanno pensando a come fare in modo che le persone clicchino sui banner pubblicitari”.
È un’iperbole, ma con un fondo di verità: la pubblicità online è un animale che ha bisogno di essere continuamente alimentato. Intanto, la spesa globale nel settore cresce di anno in anno.
Eppure il sistema che regola la pubblicità online è una delle cause primarie di diffusione della disinformazione, ed è stato tra le principali ragioni della rottura del patto di fiducia tra lettori e giornali consumatasi negli ultimi anni.
Mi trovo spesso a ragionare sul ruolo dell’advertising, sulle sue dinamiche e sulle conseguenze che ha sui media, e in questi ultimi giorni ho fatto qualche riflessione che voglio condividere con te.
Poi fammi sapere che ne pensi, se ti va.
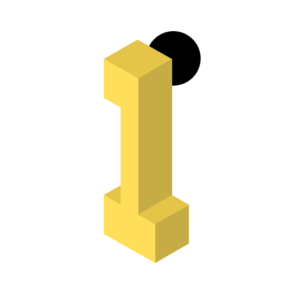
Il web si è evoluto. La pubblicità invece è rimasta ferma agli anni Novanta.
Il primo banner della storia fu pubblicato nel 1994 su HotWired.com da una compagnia telefonica, AT&T.
Sfiga volle che l’esperimento funzionasse alla grande: il 44% degli utenti cliccò sulla pubblicità, generando grande entusiasmo e aspettative.
Sembrava una rivoluzione: i banner digitali avrebbero permesso agli inserzionisti di raggiungere migliaia di persone in pochi secondi, agli utenti di acquistare il prodotto in un click e, soprattutto, a tutti di misurare l’efficacia di una pubblicità con precisione sartoriale—qualcosa che non sarebbe mai potuto succede su un quotidiano, in radio o in televisione.
Avanti veloce un quarto di secolo, tuttavia, e vediamo che lo scenario non è esattamente quello fiabesco che alcuni s’erano immaginati: la corsa all’ultima impression ha generato un web pieno di trappole, dove ogni bottone può trasformarsi in una minaccia e l’icona “x” è diventata più rara e preziosa del tesoro sepolto in un’isola.

Accurata rappresentazione fotografica di utente in procinto di aprire un sito web.
I modelli sono novecenteschi—ancora oggi la pubblicità è concepita ancora come “interruzione” dell’esperienza di fruzione, che sia la visione di un video o la lettura di un articolo.
Inoltre coi banner difficilmente si diventa ricchi: gli introiti sono troppo bassi, e questo forza i siti a trovare nuovi modi per generare più visualizzazioni (per capirci, il trend nel post-covid è l’aumento dei refresh automatici degli spazi pubblicitari).
Eppure, anche chi ha cercato di innovare questo modello e di trovare una nuova ‘formula magica’, penso a siti di informazione come The Outline e Quartz, non ha avuto fortuna. E quindi – mi chiedo e ti chiedo – come se ne esce?
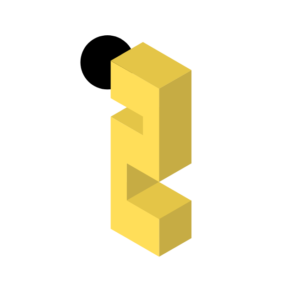
Le scelte pubblicitarie sono scelte politiche. Sarà sempre più così.
Già negli anni Sessanta, la compagnia americana Delta chiedeva ai giornali di non impaginare la sua creatività accanto ad articoli che parlassero di disastri aerei.
È il concetto di brand safety, un patto di garanzia tra editori e inserzionisti che funziona pressappoco così: io ti compro alcuni spazi pubblicitari, e tu mi garantisci che il mio logo non finisca accanto a contenuti considerati troppo negativi, dissonanti, o politicamente divisivi.
Col digitale questo meccanismo è diventato molto più efficiente. Oggi gli inserzionisti hanno a disposizione delle ‘liste nere’ dove segnare tutti gli argomenti che ritengono più dannosi per il proprio messaggio commerciale.
I filtri dei sistemi di erogazione delle pubblicità fanno il resto, evitando che i banner di quell’inserzionista finiscano in pagine web sgradite.
E così, durante le recenti proteste per i diritti delle persone di colore negli Stati Uniti, diversi brand hanno prontamente aggiornato le loro blacklist per bloccare argomenti come “Black Lives Matter,” “George Floyd,” “protest” e “Black people”.
Il risultato? Secondo una ricerca recente di Vice Media, i contenuti collegati alla morte di Floyd e alle proteste di BLM hanno portato in media all’editore il 57% di introiti in meno rispetto al resto dei contenuti del sito.
Mi chiedo, quanti di questi marchi sono gli stessi che hanno pubblicato quadrati neri sui propri profili Instagram, diramato comunicati a supporto delle proteste di piazza via LinkedIn, e aderito alla campagna Stop Hate For Profit fermando le pubblicità su Facebook—accusando la piattaforma di generare profitti sulla diffusione di contenuti razzisti e “contrari ai principi di giustizia e uguaglianza”?
Nota a margine: per chi oggi ha tra i 15 e i 25 anni, l’impegno dei brand nella difesa di valori come l’antirazzismo o la sostenibilità ambientale è un fattore fondamentale nell’orientare la scelta di acquisto.
Ma dev’essere un impegno reale, non di facciata.
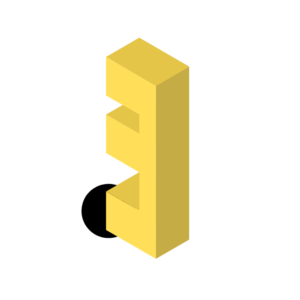
Non solo l’informazione. Anche la pubblicità online ha le sue camere dell’eco.
E spesso a crearle è chi lavora nel settore, o le istituzioni che lo regolano, tramite metriche sbagliate e approcci troppo autocompiacenti sui dati.
La prima camera dell’eco è ciò che gli economisti chiamano effetto di selezione, che in pubblicità si traduce più o meno così: alcune campagne sembrano funzionare molto bene solo perché colpiscono audience già interessate al prodotto.
Nel 2011 un professore di Berkeley scoprì che eBay stava buttando 20 milioni di dollari all’anno di pubblicità sui motori di ricerca a causa di questo approccio distorto.
Oggi l’effetto di selezione è più vivo che mai—e prolifera su ogni piattaforma, da Bing a Facebook, ed è reso ancora più forte dal ruolo crescente giocato dagli algoritmi.
La seconda camera dell’eco è relativa alla viewability, ovvero la metrica che attualmente regola il mercato dei banner pubblicitari.
{La regola: almeno il 50% del banner dev’essere visibile nella schermata per minimo un secondo. In tal caso è considerato viewable, e genererà un guadagno. Altrimenti, no.}
Come anche le impression, la viewability è però una metrica monca: ci dice solo che il banner è rimasto ‘in vista’ per pochi istanti, e parzialmente. Non ci dice se l’utente lo abbia davvero visto, se abbia letto una parte del messaggio, né quale.
E per quanti secondi, poi? Uno? Tre? Sette? La lettrice avrà compreso il contenuto dell’inserzione, oppure avrà solamente perso del tempo per cercare, disperatamente, l’agognata icona “x”?
Nel momento in cui il mercato decide che questa metrica diventa la misura del successo di una campagna, allora chi offre spazi pubblicitari sarà spinto a cercare sempre nuovi modi per raggiungerla.
Se è sufficiente che una porzione minima di un banner (PMB, brevetto questa metrica!) venga posizionata davanti agli occhi dell’utente per il minimo tempo necessario possibile (MTNP, anche questa non è male!) in modo tale da generare un guadagno, il mio primo obiettivo diventerà quello, e non la ricerca di maggiore qualità.
È un problema endemico, temo: in questo business i risultati a breve termine contano troppo. Ma sono gli effetti negativi a lungo termine che dovrebbero preoccuparci di più.
Tu che approccio hai verso la pubblicità?
Alla prossima Ellissi
Valerio
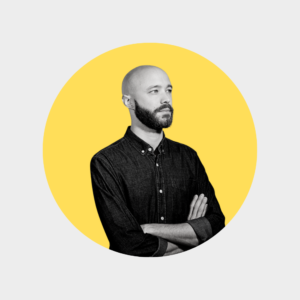 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
