Verrà la creator economy e avrà le nostre occhiaie
👋
Ciao, stai leggendo Ellissi,
la newsletter settimanale
di Valerio Bassan su media
e digitale.
Arriva ogni due venerdì,
è gratis, e puoi riceverla
anche tu.
Questa è una Ellissi speciale: è la prima puntata di un nuovo format, Ellissi Meets, che vorrei portare avanti anche in futuro: il primo ospite è Francesco Costa. Ma ci arriviamo tra poco.
Il digitale, come sai, ha spazzato via i vecchi modelli di business e creato spazi di mercato completamente nuovi: uno dei più rivoluzionari è rappresentato, senza dubbio, dall’ascesa della creator economy.
È un tema che mi tocca da vicino, sia professionalmente, sia personalmente: da quando nel 2012 co-fondai un magazine online per italiani a Berlino a oggi, ho sempre cercato di tenere le mani occupate con qualche progetto individuale più o meno redditizio (ok: meno).
La creator economy non è una cosa totalmente nuova, no.
La prima piattaforma di crowdfunding, ArtistShare, nacque nel 2000. Il Partner Program di YouTube, che permise per la prima volta di monetizzare i video sulla piattaforma, esordì nel 2007.
Kickstarter e Indiegogo videro la luce tra il 2008 e il 2009. Patreon, una delle principali piattaforme di gestione delle membership a pagamento, fu fondata nel 2013. E già dal 2014 Ben Thompson lavora a tempo pieno a Stratechery, la sua popolarissima newsletter sulla tecnologia.
I germi erano già tutti lì. Qualcosa però nel frattempo è cambiato.
Che cosa, esattamente?
Negli ultimi anni si sono democratizzati (e moltiplicati) gli strumenti digitali di monetizzazione, e sono nate nuove piattaforme, come Substack e OnlyFans, che permettono a chiunque di offrire contenuti in cambio di abbonamenti e donazioni, in pochi clic.
Mentre le barriere tecnologiche di accesso alla reader revenue si abbassano, online si trovano già dozzine di libri, corsi ed eventi che spiegano come lanciare un proprio progetto individuale sfruttando la crisi (o meglio, il rinnovamento) dei modelli di business nel digitale.
Tutte queste ragioni sono, allo stesso tempo, causa e conseguenza del nuovo paradigma. Dove prima non c’era che qualche bancarella, oggi si è innestato un intero mercato. Quello, appunto, della creator economy.
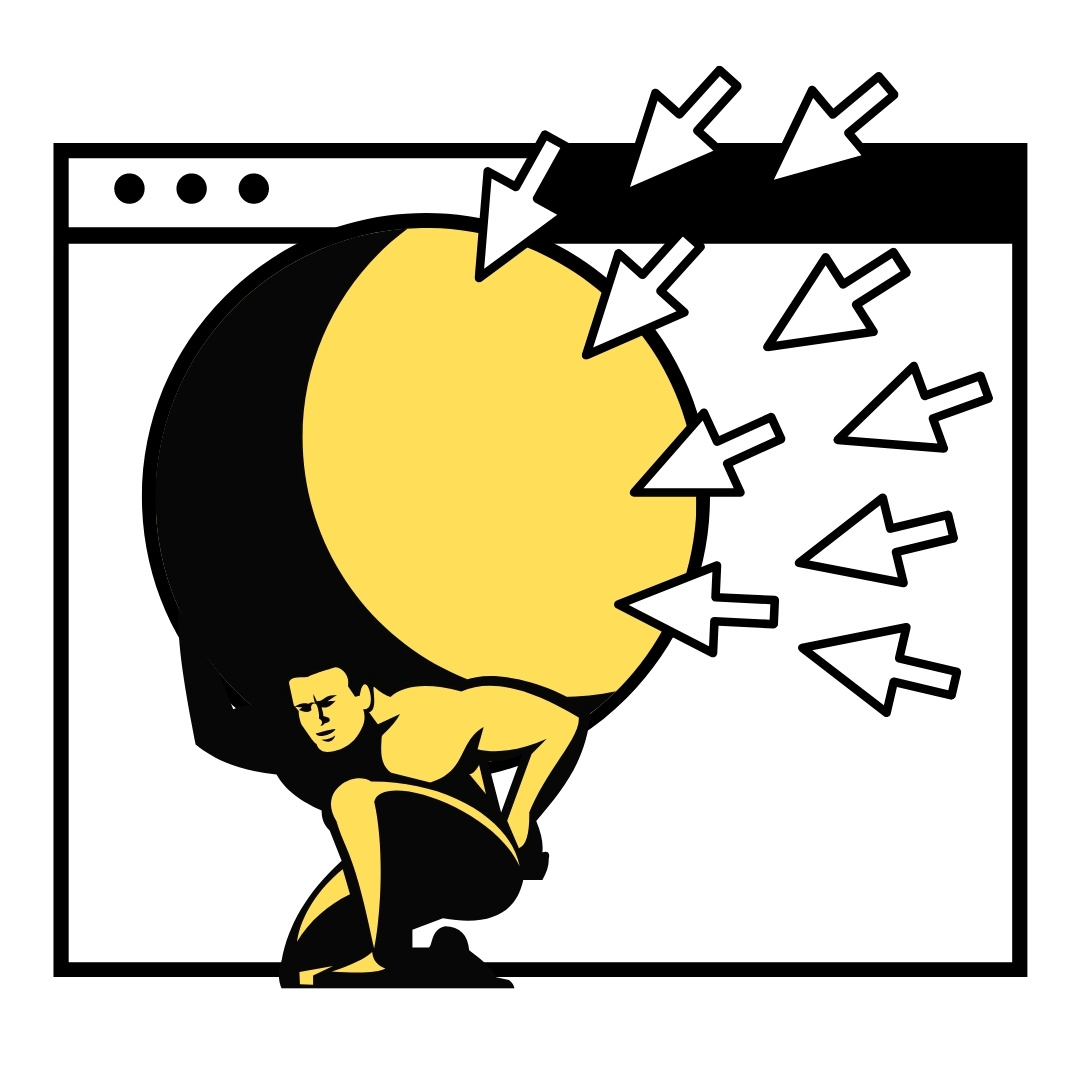
Faccio una piccola digressione: non amo il termine creator economy (è troppo parziale: e la curator economy? e la celebrity economy?) ma le alternative – passion economy o niche economy, per dirne due – sono ancora meno adatte a raccontare un mondo così vario e frammentato.
Parlerei piuttosto di economia della relazione, o di economia della monetizzazione individuale, usando termini che descrivono il processo più che il prodotto o la persona.
La grande innovazione è infatti, secondo me, il rapporto diretto che ogni creator può instaurare con la propria audience, anche senza beneficiare di una struttura organizzativa o di risorse produttive che non siano le proprie. È una relazione nuova che cambia persino le regole della celebrità. Come ha scritto il New York Times, “the new model media star is famous only to you”.
Comunque lo si voglia chiamare, questo fenomeno coinvolge milioni di individui, di ogni età e background professionale (anche attempati giornalisti: ne avevo parlato qui e qui).
E un po’ come in qualsiasi sistema liberista, questa nuova economia ha generato alcune disuguaglianze: 1% gets rich, 99% dies trying.
Recentemente, su questo tema, la Harvard Business Review ha parlato della necessità di costruire una classe media della creator economy.
In molti casi infatti a vincere il creator game sono sempre gli stessi: è la legge della transumanza digitale, in cui gli individui di maggior successo sono quelli che hanno già un proprio seguito su un’altra piattaforma, e che sono in grado di trasportare il gregge da un pascolo all’altro.
Ma i creator digitali non soffrono di solitudine?
Da un lato, la vita dei solopreneur è elettrizzante. Sei indipendente. Hai totale libertà creativa. Guadagni facendo quello che ti piace davvero. Impari tantissimo, anche dai tuoi errori.
Dall’altro, però, è una vita totalizzante: gestire in autonomia produzione, delivery e monetizzazione di un progetto è un impegno immenso. Per questo l’era dei creator è anche l’era del creator burnout.
Prendo in prestito le parole di Molly Baz, che l’anno scorso ha lasciato la redazione di Bon Appétit per aprire un club di video-ricette a pagamento su Patreon. Nel descrivere il suo nuovo progetto, Baz dice: “Non c’è nessun altro a prendersene cura. Il successo del mio brand e del mio mondo sono direttamente proporzionali alla quantità di energia che ci investo”. Se ti fermi, insomma, si ferma tutto. Puf.
Per parlare di questi e di altri argomenti, ho deciso di invitare su Ellissi un ospite speciale — uno che dal 2015 ha scelto di vivere due vite parallele: vicedirettore de Il Post di giorno, creator di Da Costa a Costa di notte.
Ma Francesco Costa non è un supereroe, e il suo progetto non è un miracolo.
Il motivo per cui gli ho voluto fare qualche domanda, è che Da Costa a Costa racchiude tanti degli elementi-chiave che ci possono aiutare a capire cos’è questa diavolo di creator economy.
Primo, Da Costa a Costa è un progetto multipiattaforma: newsletter, podcast, video-approfondimenti su Instagram.
Secondo, ha un focus verticale: parla di un solo tema, gli Stati Uniti, e lo fa con estrema cura e profondità.
Terzo, è invecchiato davvero bene: nel corso del 2020, anno di covid e di elezioni americane, la community di Da Costa a Costa ha raggiunto numeri imponenti.
Gli iscritti alla newsletter sono triplicati, così come gli ascolti del podcast, mentre i follower di Costa su Instagram sono otto volte quelli di un anno fa.
Per parlare meglio queste e di altre cose, ho fatto qualche domanda a Francesco, che ha da poco pubblicato il suo secondo libro, Una storia americana.

◼ Cominciamo. Da Costa a Costa nasce nel 2015: pur avendo mantenuto la propria anima gratuita (sia la newsletter che il podcast erano e restano free), sei riuscito a garantire al progetto solidità economica, diversificando le revenue. Potresti spiegare ai lettori di Ellissi come si struttura il modello di business del progetto? A livello di fiscalità, invece, che difficoltà hai incontrato?
[fc] Facendo una stima grossolana, nel 2020 il 60% dei ricavi è arrivato dalle donazioni di iscritti e ascoltatori di Da Costa a Costa, tutte erogate senza avere nulla in cambio, nemmeno un contenuto premium o una ricompensa intangibile, solo la soddisfazione di aver permesso a quei contenuti di esistere. Un altro 15% dalla pubblicità e il restante 25% dai libri, che pure hanno venduto molto. Sul piano economico ho ricavato da Da Costa a Costa – al lordo di costi e soprattutto tasse – oltre il triplo della mia RAL da vicedirettore al Post, che è la mia occupazione principale (ed è un’ottima RAL). Insomma, è un lavoro che sarebbe sostenibile, e non è difficile immaginare che se facessi solo Da Costa a Costa i ricavi potrebbero anche aumentare. Produrrei più contenuti, di miglior qualità, con un modello di business meno improvvisato, eccetera. Dato che invece è una cosa che faccio nel tempo libero, cioè la sera, la notte, all’alba, nei weekend, l’impegno richiesto per me non è sostenibile nel lungo periodo. Ma per il momento non ho intenzione di fare il salto. Il mio lavoro al Post mi piace, e soprattutto mi permette di incidere sull’informazione italiana molto più di quanto possa fare da solo. O forse non ho la cultura imprenditoriale degli americani, ma su questo ti dico meglio dopo.
Sulle tasse: la legge italiana non prevede l’esistenza di una cosa come Da Costa a Costa. E quindi il quadro cambia secondo la norma – scritta pensando ad altre fattispecie – che decidi di prendere in considerazione. In termini di legge, per esempio, le donazioni sono esentasse: soprattutto se non ci sono ricompense di alcun tipo. Tutti gli esperti che ho consultato dicono però che un giorno l’Agenzia delle Entrate potrebbe bussare alla mia porta per avere chiarimenti e io dovrei spiegargli cosa sia Da Costa a Costa e convincerli che non è stato messo in piedi per eludere il fisco. Il consiglio è stato unanime: paga. Ovviamente è quello che farò. Se ne andrà una buona metà di tutte le donazioni ricevute.
◼ Sul sito di Da Costa a Costa c’è un tasto con scritto “Scrivimi, rispondo”: un ‘comandamento’ che andrebbe applicato molto di più nelle redazioni. Immagino che la crescita del progetto nell’ultimo periodo abbia sicuramente intensificato la mole di domande o messaggi che ti arrivano, e non solo per email. Quanto tempo di Da Costa a Costa dedichi al rapporto con la tua community?
[fc] All’inizio del progetto ho deciso che avrei sempre risposto a tutti quelli che mi avrebbero scritto. Lo faccio ancora, anche se è diventato più difficile: parliamo di almeno un centinaio di messaggi ogni giorno tra email e Instagram, che è di gran lunga il social media che uso di più. Quando c’è una notizia grossa – i confronti tv, le elezioni, l’attacco del 6 gennaio – i messaggi per un po’ diventano cinquecento o seicento al giorno. Faccio tutto da solo. Certo, in molti casi me la cavo con un “grazie”, ma sono comunque messaggi che devi aprire, leggere, a cui devi rispondere. E sono frequenti anche le risposte da tremila battute, chi ti chiede di ripescare questo o quel link, chi ti fa una critica a cui ha senso dare una risposta pensata, chi chiede un consiglio di carriera, chi qualcosa da leggere, chi una conversazione telefonica per la tesi di laurea, chi una copia autografata del libro… nei limiti del possibile cerco di dire sì a tutti. E il fatto che io dica “scrivetemi, rispondo” incentiva le persone a farlo. Credo sia semplicemente una parte del lavoro: faticosa, ma anche gratificante e istruttiva. E il risultato è che nel tempo sono entrato in contatto personalmente con decine di migliaia di persone. Decine di migliaia di persone che mi hanno raccontato qualcosa della loro vita, che poi mi riscrivono per ringraziarmi di un consiglio che gli ho dato, che rispondono alla mia opinione con una loro opinione… persone con cui ho creato un contatto diretto. E se vivono negli Stati Uniti diventano anche delle fonti per il mio lavoro. Secondo me questa è la singola cosa che più di ogni altra ha contribuito a creare una vera community – esigente, solida, affettuosa e disposta a pagare – attorno alle cose che faccio.
◼ Visto da fuori, Da Costa a Costa sembra la creazione di una band, più che di un solista. Durante le elezioni dello scorso anno, il numero dei tuoi follower è cresciuto proporzionalmente alle occhiaie — senza dimenticare che hai anche un lavoro a tempo pieno, e che hai scritto un nuovo libro. Sei mai stato vicino al burnout? Come sei riuscito a trovare un equilibrio?
[fc] Non sono andato in burnout, e se mi fosse capitato sarebbe stato difficile capire se dare la colpa al “creator stress” o al maledetto 2020. Però non voglio eludere la domanda. Il lavoro per Da Costa a Costa nel 2020 è consistito nello scrivere una lunga newsletter ogni settimana e produrre un podcast da 40 minuti ogni due settimane, e sono contenuti che richiedono ricerca, studio, attenzione. Poi ci sono il rapporto con la community, i contenuti quotidiani su Instagram, gli incontri online, i libri da promuovere… tutto sempre e solo nel tempo libero cosiddetto. Il lavoro ha pagato, per fortuna: la newsletter è passata in un anno da 15.000 a 50.000 iscritti, il podcast è decollato, il primo libro ha venduto benissimo e ne ho scritto un altro che sta vendendo ancora meglio, su Instagram sono passato da 20.000 a 160.000 followers, sono finito a commentare l’insediamento di Biden al TG1 delle 20. Non è successo all’improvviso, però. Ho creato Da Costa a Costa nel 2015, è cresciuto anno dopo anno e ho passato l’intero 2020 a lavorare ogni giorno dalle 5 del mattino fino a notte inoltrata (al Post dalle 7 alle 18, in un giorno normale, a Da Costa a Costa nel resto del tempo), spesso anche nei weekend. Questo anno balordo mi ha aiutato: per come sono fatto, meglio lavorare che fare il pane. Ma non è un caso se a dicembre ho sospeso Da Costa a Costa: non ce la facevo più.
◼ In questa newsletter parlo spesso – anche criticamente – della creator economy, e del proliferare di nuove piattaforme che permettono ai singoli di monetizzare la propria audience anche senza appartenere a una media company. Se non sono molti quelli che “ce la fanno” (il 2% dei creator di Patreon in USA, nel 2017, è riuscito a raggiungere il salario minimo mensile), quelli che riescono davvero a mantenersi sono ancora meno, uno zero virgola. “Volare da soli” non è certo facile: richiede costanza, competenze e qualità. Il rischio è di vendere un sogno che non esiste? Oppure siamo davanti a una giusta legge di mercato?
[fc] Onestamente non lo so, però azzardo: non sarà che produrre contenuti per cui valga la pena pagare è molto più difficile di quanto sembri? A me che ci riescano il 2 per cento di quelli che ci provano sembra già un dato straordinario. Qual è la percentuale di persone che riesce a vivere giocando a calcio, rispetto a quelle che ci provano? Non parlo di Ronaldo, dico le persone che campano di quello, anche quelle che giocano in Serie C. Vorrei vedere un dato, ma a naso direi che siamo molto sotto il 2 per cento. Credo che sia lo stesso anche per scrittori e scrittrici, musicisti e musiciste, e temo anche per chi lavora nel giornalismo. Il tempo che le persone possono dedicare a informarsi è poco: e questo nel migliore dei casi, cioè i casi di chi vuole informarsi. Quante newsletter può leggere una persona che lavora in ospedale tutto il giorno? Le opportunità per i “creator” cosiddetti si sono moltiplicate, ma questo ha reso ancora più serrata la lotta per l’attenzione delle persone. E il tempo è una risorsa finita.
◼ Negli Stati Uniti, di cui sei acuto osservatore, molti giornalisti affermati hanno scelto di lanciare una newsletter o un progetto indipendente — da Emily Atkin (Heated) a Judd Legum (Popular Information), fino ad arrivare al co-fondatore di The Intercept, Glenn Greenwald. La costruzione di una relazione diretta tra giornalista-creator e la sua nicchia sta contribuendo alla disintermediazione del lavoro giornalistico, e non solo a livello economico. In Italia ci sono alcuni esempi, ma nulla di proporzioni simili. Pensi che questo trend si possa diffondere ulteriormente anche da noi?
[fc] Almeno finché restiamo al giornalismo, il fenomeno in questione ha connotati molto americani e soprattutto “non italiani”. Dimensioni e sensibilità del mercato, standard qualitativi, mobilità occupazionale, cultura imprenditoriale, permeabilità con altri settori… siamo su due galassie diverse. Noi abbiamo una vocazione all’imprenditorialità e al rischio infinitesimale, rispetto alla loro, un mercato piccolo e poco abituato a pagare, centri media e inserzionisti pigrissimi, legislazioni rigide e obsolete. La disintermediazione di cui parli, buona o cattiva che sia, non so se qui la vedremo mai. Progetti indipendenti interessanti sì, certo. Ci sono già e ne vedremo altri. Ma progetti indipendenti con una vera sostenibilità economica, capaci di farsi preferire a carriere nei media tradizionali e a solidi contratti “a tempo indeterminato”, un’altra cosa che in America non esiste? Che siano messi insieme da personaggi di ottimo posizionamento nei settori più remunerativi dell’industria, e che siano così tanti da far parlare di un trend? Mi piacerebbe, ma credo che qui non accadrà. Ed è un peccato, perché alcune condizioni favorevoli ci sarebbero.
E questo è tutto, per oggi.
Valerio
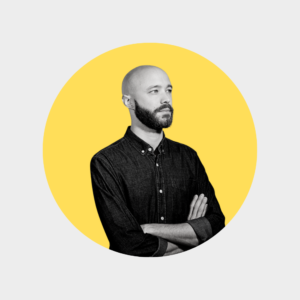 Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
Ciao, mi presento. Mi chiamo Valerio Bassan e lavoro come consulente di strategia digitale nel mondo dei media e del giornalismo, per clienti italiani e internazionali. Questo post è tratto da Ellissi, la mia newsletter settimanale. Iscriviti qui.
SE VUOI APPROFONDIRE
